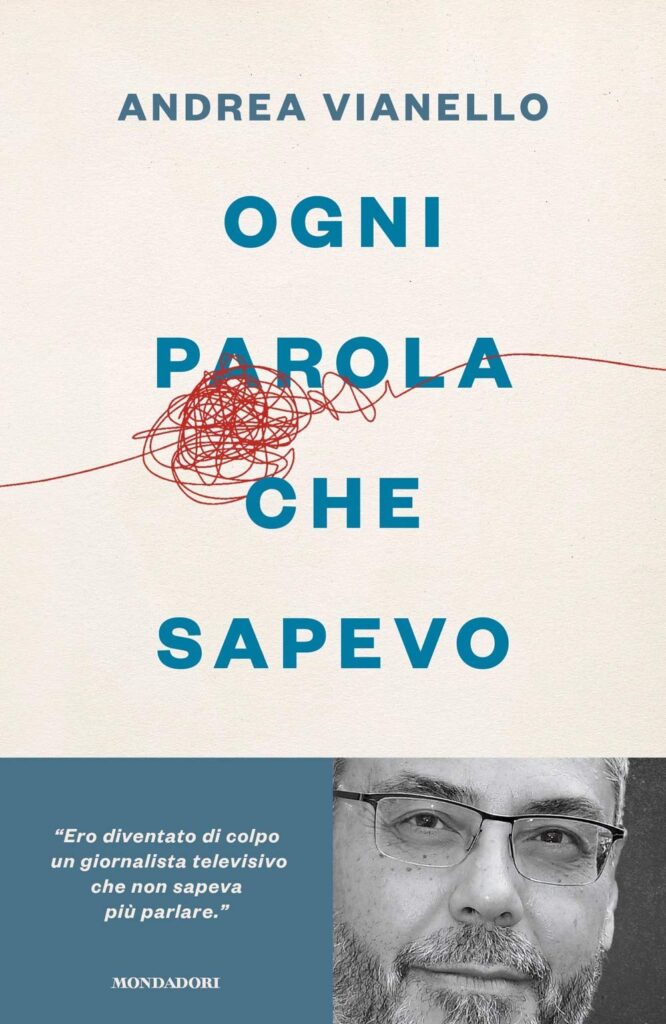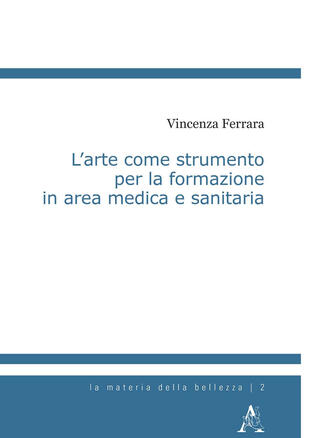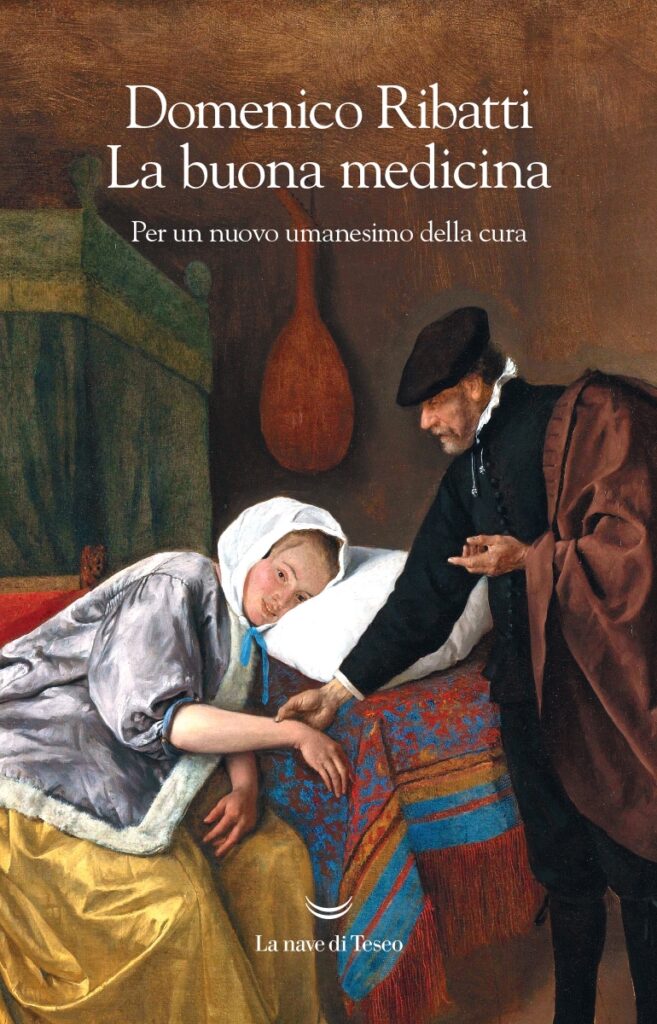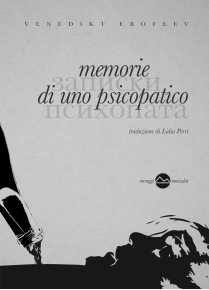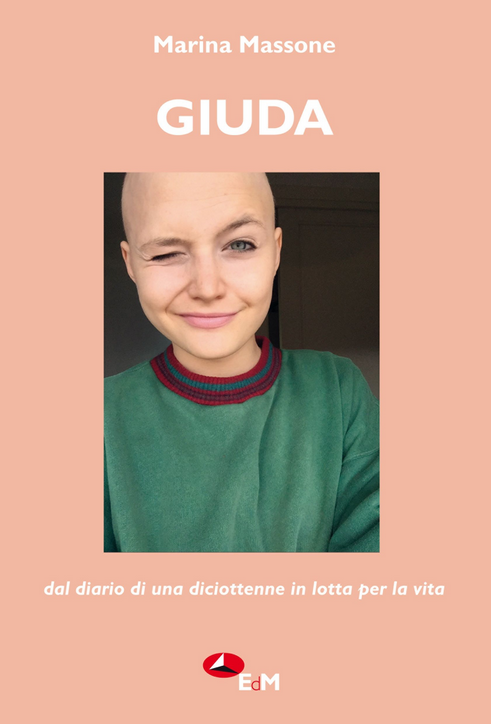Una malattia chiamata Solitudine
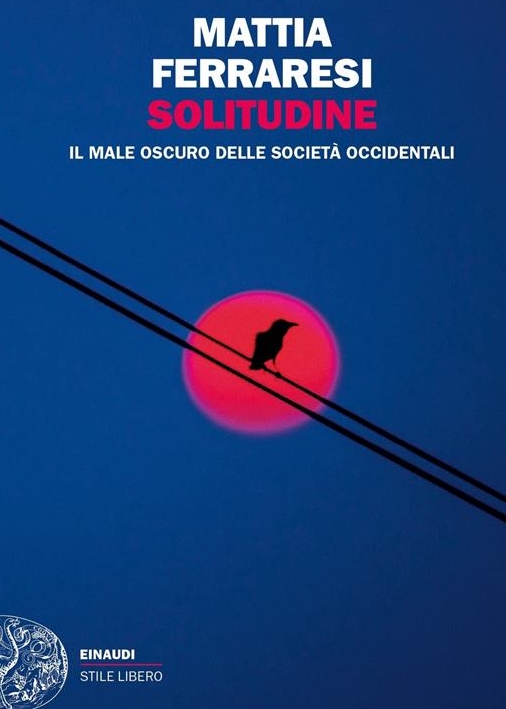
Secondo Mattia Ferraresi, giornalista del quotidiano “II Foglio” e corrispondente del “New York Times”, è questo “Il male oscuro delle società occidentali”, una patologia del nostro tempo, frutto dell’individualismo e dell’autocompiacimento che si sublima nel selfie. Al punto che l’Inghilterra ha creato un ministero ad hoc
L’autore Mattia Ferraresi – giornalista del quotidiano “II Foglio” e corrispondente del “New York Times” che così ama descriversi: “Nato nella terra di Virgilio e cresciuto in quella di Tassoni, ora vivo nel quartiere di Tony Manero” – nel suo ultimo libro dal titolo “Solitudine” (Einaudi), affronta il tema soffermandosi in particolare sul “nuovo narciso”. Una “figura ben più tragica di quella antica. Il Narciso della mitologia, condannato ad amare solo se stesso, sa che si tratta di una condanna e non di un dono. Il nuovo narciso non ha questa percezione, è così immerso nel suo individualismo che non ha nemmeno gli strumenti per rendersi conto di questa prigione interiore”, sostiene l’autore. “Pensa che concentrarsi su di sé e sulle proprie potenzialità sia una forma di emancipazione, un modo per superare tutto ciò che lo ha oppresso: autorità, gerarchie, partiti, chiese, convenzioni. Ed ecco che si ritrova solo. Il selfie è il meccanismo perfetto per il nuovo narcisista, che interpreta e presenta ogni cosa in relazione a sé”.
Al tema della solitudine è stata dedicata un’ampia letteratura. Per esempio, in “Solitudine” di John T. Cacioppo e William Patrick (il Saggiatore), gli autori sostengono che privarsi dello scambio con gli altri provoca uno strappo nel tessuto genetico che si espande nel nostro essere fino a pervadere le emozioni, e propongono al lettore le acquisizioni più avanzate della ricerca per la diagnosi e la cura di quella che ritengono una delle più diffuse “malattie” del nostro tempo. Secondo Ferraresi, invece, la solitudine è frutto di un individualismo, di un autocompiacimento che diventa una prigione. La scrittrice francese nota con lo pseudonimo di Colette scrisse: “Ci sono giorni in cui la solitudine è un vino inebriante che ti ispira libertà, altri in cui è un tonico amaro, e altri ancora in cui è un veleno che ti fa sbattere la testa contro il muro”.
Negli ultimi 400 anni l’ideale di liberazione dell’uomo, nello sviluppo delle società occidentali, si è affermato come indipendenza dall’altro, liberazione del singolo da tutte le costrizioni, siano esse leggi, autorità, gerarchia sociale. Questo processo di scardinamento delle relazioni profonde con l’altro è riuscito, ma ci si è resi conto che il tipo di società che ne è derivato non è garanzia di felicità, generando così – aggiunge l’autore – un paradosso: “I governi oggi cercano di combattere quello che essi stessi hanno generato e approvato”. O cercano, diciamo meglio, di correre ai ripari per curare questa sorta di epidemia che abbiamo deliberatamente diffuso, e da cui ci siamo fatti volontariamente contagiare.
L’Inghilterra è arrivata a creare il primo “ministero per la Solitudine” in Europa, nella consapevolezza che questa condizione è correlata ad altri disagi, patologie, disabilità croniche dagli effetti preoccupanti. Secondo una ricerca condotta della Brigham Young University nello Utah (Usa), l’isolamento ha un impatto così forte sull’organismo da aumentare del 30% la predisposizione dell’individuo ad ammalarsi.
Patrizio Mignano
Mattia Ferraresi, “Solitudine”, Einaudi (2020)
Fonte: Almanacco CNR – Recensioni