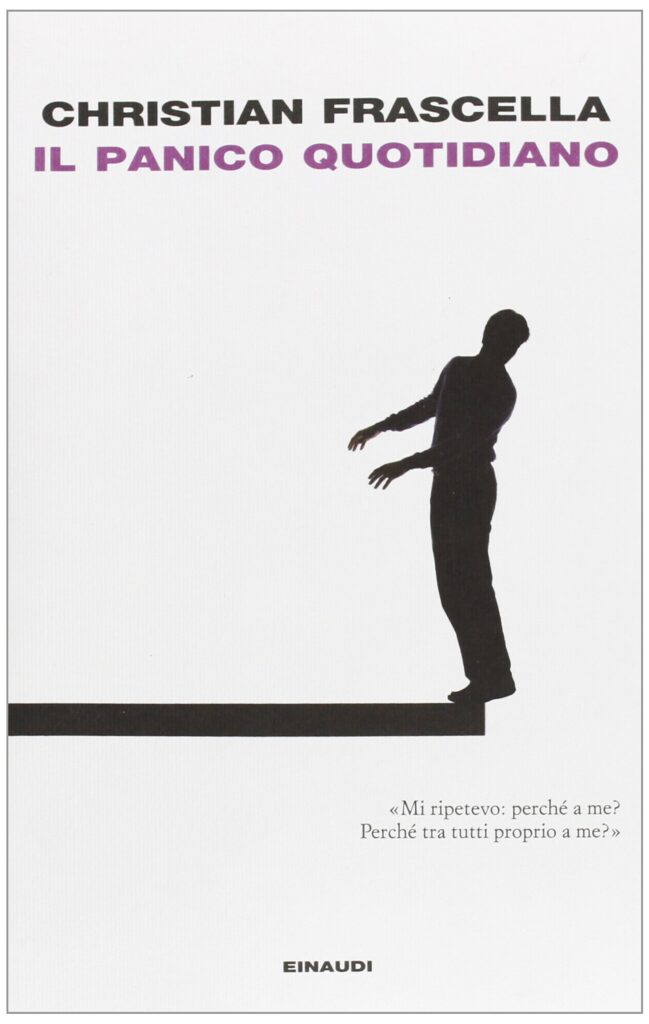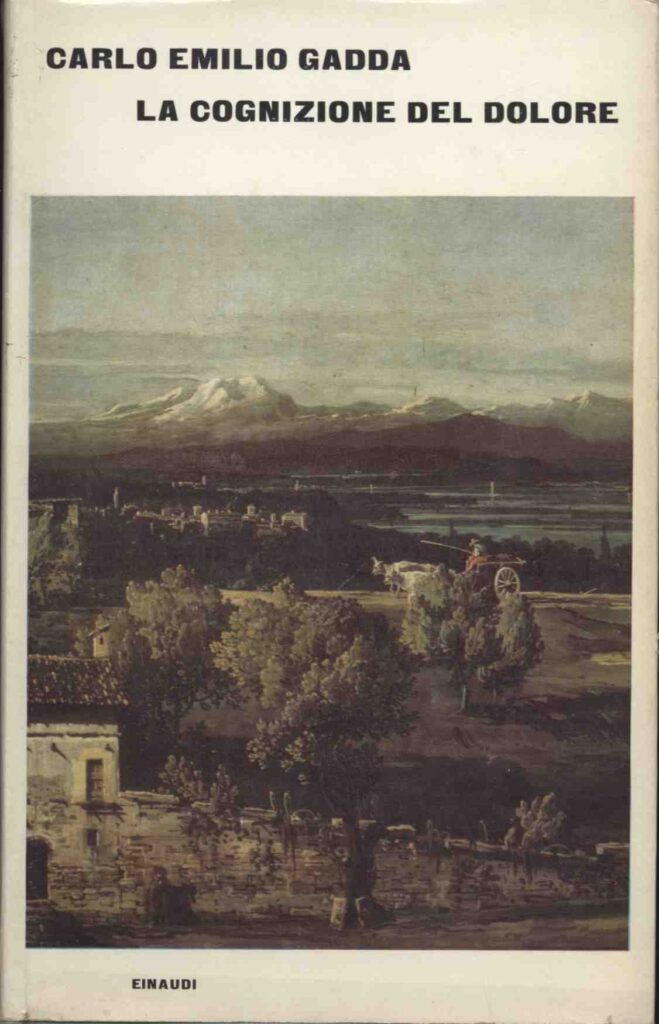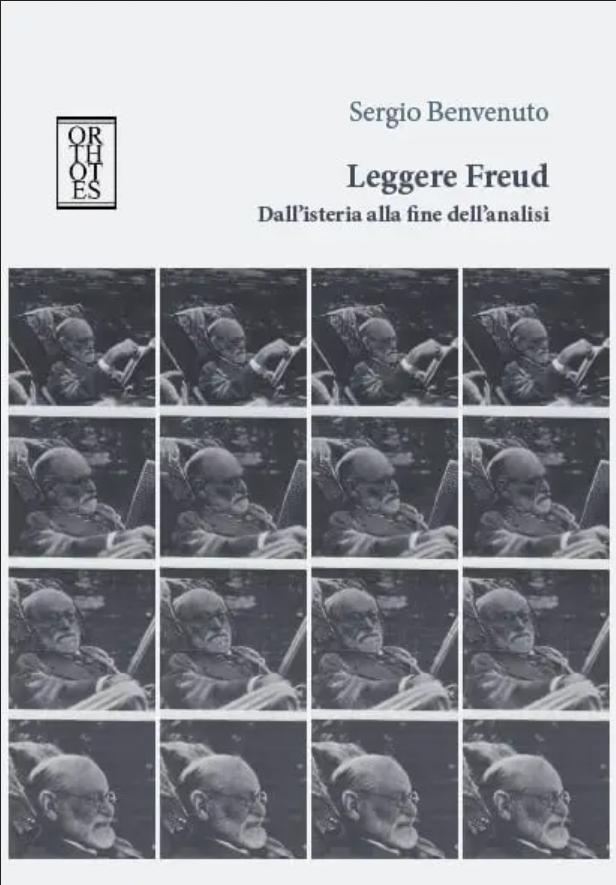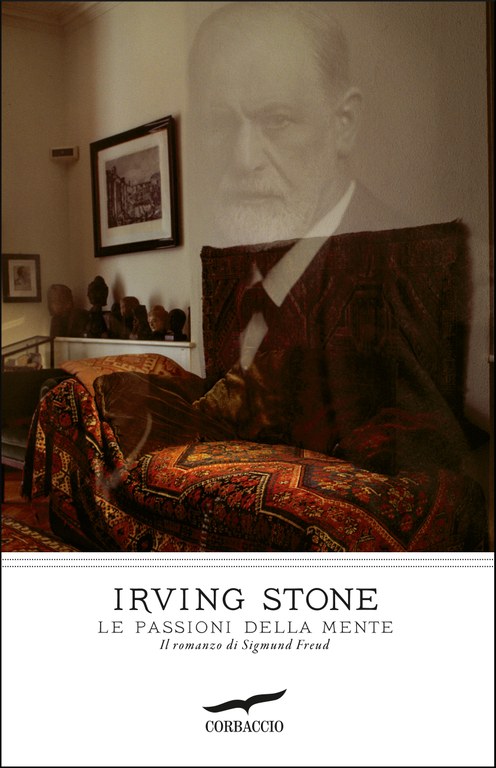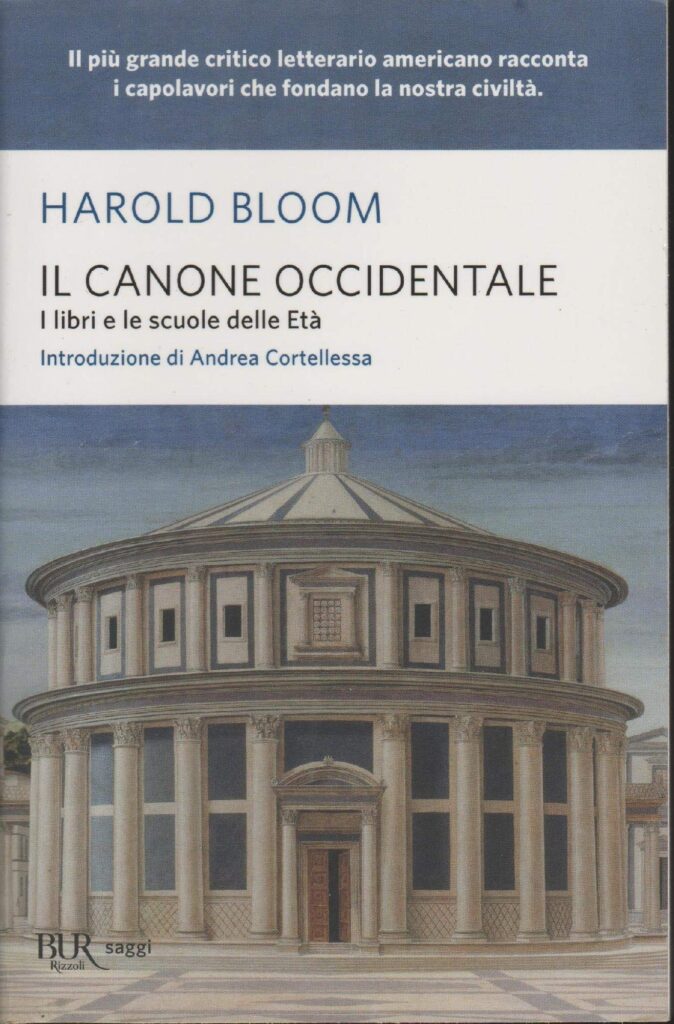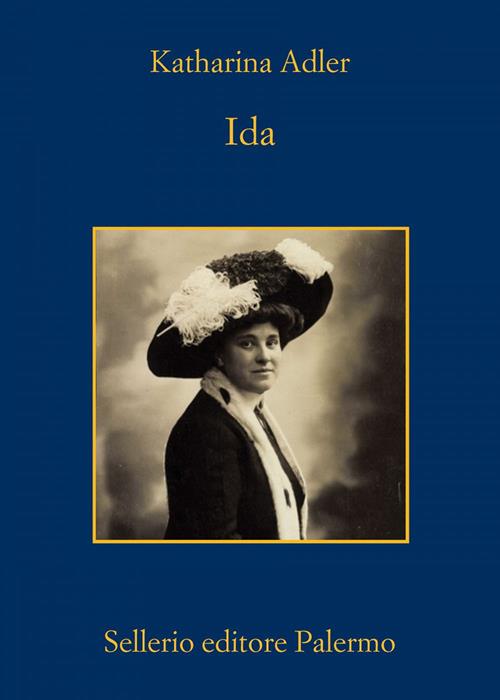Tutti i racconti di Berto. L’alter Zeno della letteratura italiana


Giuseppe Berto: scrittore, drammaturgo e sceneggiatore. Una notevole vita tra onorificenze, opere letterarie e molto altro
Noto soprattutto per “Il male oscuro”, che su queste pagine abbiamo definito come il più importante romanzo italiano sulla psicanalisi insieme con “La coscienza di Zeno”, Giuseppe Berto fu anche un prolifico autore di racconti, che raccolti a suo tempo dallo scrittore stesso e ora nuovamente usciti in volume con la Bur. Al tema del male di vivere, qui, si accompagnano molti altri spunti, in particolare i ricordi militari dell’autore che formano in titoli quali: “La colonna Feletti”, “Avvenimento a Hereford”, “Sosta a Cassino”, “La vita militare”.
La scrittura tracima spesso nell’autobiografia vera e propria. Né vi è alcuna distinzione, in fondo nella narrativa bertiana, tra questi due aspetti, l’introspezione e la memoria. Tutte le scelte compiute dall’autore furono infatti improntate a una continua ‘uccisione del padre’: la scelta di arruolarsi, di combattere, di vestire la divisa fascista e rifiutarsi di collaborare con gli alleati, e poi quelle di ingaggiare contro la consorteria intellettuale a lui coeva una guerra polemica inesausta e dagli accenti talvolta eccessivamente acrimoniosi.
Lo scrittore di Mogliano Veneto, pure, ebbe ammiratori del calibro di Hemingway, ottenne un notevole riscontro anche all’estero e agguantò tra l’altro con ‘Il male oscuro’, nel 1964, una straordinaria doppietta: premio Viareggio e Campiello. Ma nemmeno il successo poté lenire un’insoddisfazione esistenziale che affondava in un rapporto così intimo e compromesso, che ebbe il suo climax con l’agonia paterna.
Giuseppe Berto fu “ostracizzato con livore oppure trascurato con simulata indifferenza quando era in vita” ed “è tuttora celato dalla cortina della rimozione letteraria”. L’affermazione di Paola Culicelli può essere difficilmente smentita. “Per qualche motivo sull’autore grava una damnatio memoriae”, prosegue l’autrice del saggio “La coscienza di Berto” sullo scrittore di Mogliano Veneto che, pure, ebbe ammiratori del calibro di Hemingway, ottenne un notevole riscontro anche all’estero e agguantò tra l’altro con ‘Il male oscuro’, nel 1964, una straordinaria doppietta: premio Viareggio e Campiello.
Proprio il successo, anzi, fu probabilmente una delle ragioni dell’ostilità dell’establishment culturale, insieme con un ‘eccesso’ di fascino che lo scrittore non mancò di usare con le donne, e con la scorrettezza politica: “Dando alle stampe prima Il Brigante e poi Guerra in camicia nera“, ricorda l’autrice, egli “si inimicò” sia gli anticomunisti sia gli antifascisti. Un attacco effettivamente malmostoso a Dacia Maraini, poi, non migliorò certo i rapporti di Berto con i colleghi.
Dopo il pregevole lavoro di Dario Biagi di qualche anno fa, arriva adesso a recuperare almeno parte della distrazione dei critici questo volume che però non si configura tanto come una biografia quanto come un saggio mirato all’aspetto centrale dell’opera più famosa dell’autore, assunta quale segnavia di tutta la sua produzione. In effetti, dopo ‘La coscienza di Zeno’, come la crasi del titolo del saggio di Cucinelli vuol far intendere, ‘Il male oscuro’ rimane il più importante romanzo italiano dedicato alla psicanalisi.
“Aver coscienza di troppe cose è una malattia, una vera e propria malattia. Eppure sono convinto che non soltanto una coscienza eccessiva, ma la coscienza stessa è una malattia”, scrive Berto, il cui senso di colpa gli viene trasmesso, secondo la diagnosi piuttosto classica della studiosa, dal padre, che in effetti fu sul piano storico un tipico Super-Io, perennemente insoddisfatto del figlio, per il quale ebbe solo espressioni denigratorie e sfiduciate. Un rapporto che conobbe il suo momento topico proprio “nel frangente estremo dell’agonia paterna” e che lo scrittore tentò di risolvere con tre anni di terapia, incapaci però di liberarlo del tutto da imprinting, fobie e cicatrici caratteriali quali l’ipocondria (“la fissazione maniacale di essere ormai segnato, condannato a essere ghermito dal cancro”), le dimostrazioni di coraggio come quella esibita con l’arruolamento volontario e soprattutto uno stato depressivo cronico, a quei tempi si parlava di “esaurimento” che lo portarono a una continua “spola da un medico all’altro”, alternata alle più varie auto-prescrizioni.
Marco Ferrazzoli
Giuseppe Berto, “Tutti i racconti”, Rizzoli (2012)
Paola Culicelli, “La coscienza di Berto”, Le Lettere (2012)
Fonte: Almanacco CNR – Recensioni – Tutti i racconti di Berto
Fonte: Almanacco CNR – Recensioni – L’alter Zeno della letteratura italiana