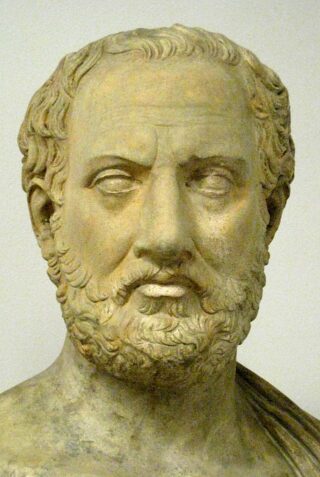Nei due brani, estratti da “Sessanta racconti”, Dino Buzzati descrive i sintomi e i segni della peste canina, capace di distruggere anche i rapporti di amicizia più saldi.
Odore di tartufo
Paurosissimo delle malattie, io le sento venire da lontano. Così, per certe voci portate da marinai, da viaggiatori, zingari, io sapevo alcuni mesi prima che la peste canina stava avvicinandosi. Se ne parlava nelle taverne del porto verso sera, quando dalle acque buie, là vicino, cominciano a uscire le superstizioni e gli incubi. Ma la gente istruita diceva che era solo una leggenda.
Di questa malattia si raccontava una quantità di cose strane: secondo alcuni proveniva dal cuore impenetrabile dell’Africa, altri invece dicevano che fosse stata provocata da un sacrilegio di Terrasanta. La chiamavano canina non perché colpisse i cani ma perché nella fase dell’incubazione, che durava uno o due giorni, l’ammalato emetteva un forte odore; il quale, a seconda dei casi, ricordava la resina, o l’aglio, o lo sterco, o la rosa e così via; ma assai più spesso ricordava il cane. E di qui il nome.
In tanti odori c’era però sempre un comune sottofondo: cioè un effluvio specialissimo, indefinibile a parole; che era lo stesso marchio della peste. É pochissimi erano in grado di distinguerlo, così da poter dire: questo è odore di peste e questo no. Si trattava di medici o infermieri, o suore che erano vissuti in Africa o in Oriente.
Altri sintomi denotavano l’esplodere della peste vera e propria. Alcuni, come i brividi, il mal di testa, le vertigini, erano comuni a molte altre note malattie. Ma ce n’era uno tipico e fatale: l’uomo colpito dal contagio non era più capace di un discorso organizzato, a un tratto il pensiero sembrava frantumarsi in una sconnessione di parole che finivano in un confuso barbuglìo. Dopo un poco magari l’ammalato riprendeva a parlare come al solito ma sempre, dopo due tre frasi, sopravveniva quell’intoppo. Perciò la si chiamava anche peste sillabica. Seguivano una grave prostrazione, vomito, delirio, e, nel giro di poche ore, immancabile la morte. Esisteva, è vero, un vaccino capace di stroncare l’infezione: ma doveva essere iniettato al tempo giusto, nel corso dell’incubazione, né prima né dopo; guai se si tardava; guai anche se lo si propinava, per errore, a una persona sana; se in seguito costui si contagiava, il vaccino non sarebbe più servito a niente.
L’allarme fu gettato all’improvviso. Un decreto del governatore, alludendo in modo vago a pericoli di epidemie, proibì gli assembramenti e gli spettacoli, chiuse i locali pubblici, impose il controllo dei viaggiatori eccetera. In poche ore tutta la popolazione seppe. E già si udivano le sirene delle autoambulanze chiamate qua e là a trasportare i moribondi. Fu il terrore.
Da quel momento, misteriosamente trasportandosi il contagio da un quartiere all’altro, tutti cominciarono a vivere nell’ansia, scrutando se stessi e i familiari, nel timore di avvertire i primi sintomi. In ogni luogo ora si vedevano perciò uomini e donne con i nasi per aria, ad annusare, se mai sentissero l’odore della peste. Ma era facilissimo ingannarsi; né si contavano le paure a vuoto. In una città popolata di cani come questa non c’era casa dove l’odore canino fosse assente; ne erano intrisi, si può dire, i muri stessi. Ciò moltiplicava i falsi allarmi.
Va da sé che, scoppiata l’epidemia, divenni l’ombra stessa del Tiriaca. Guai se non avessi potuto stargli a fianco così spesso. Col mio terrore di essere infettato, sentivo un odore dopo l’altro, immaginandomi che provenissero da me. Il Tiriaca mi rassicurava: «Ma io non sento niente ». E mi annusava col suo grande naso a becco.
Una sera -ero invitato a pranzo –appena entrato in casa del Tiriaca, sento odore di tartufo. Magnifico, dico a me stesso, perché di tartufi sono ghiotto. E già pregusto un pranzo succulento, tanto più che in questi tempi grami è una delle poche consolazioni che rimangono.
A tavola si è in due soltanto, Tiriaca ed io; la famiglia sua è partita, alle prime avvisaglie della peste lui l’ha mandata in Sicilia, da parenti. Un antipasto, una ottima zuppa, roastbeef con salsa e contorno, asparagi. A questo punto il Tiriaca mi guarda: « Cos’hai? Non ti senti bene? Sei diventato così pallido». «No, no, niente » faccio io, inchiodato da un terribile sospetto. «Ma dimmi, professore… Come mai quest’odore di tartufi?» « Tartufi?… Io non sento odore di tartufi… E tu Ines, senti qualche cosa? » « Neanch’io » risponde la domestica « di tartufi, io non ne ho adoperati, forse sarà il profumo della salsa. »
Ma anche di là, in salotto, dove passiamo a prendere il caffè, persiste la inquietante sensazione. «Scusami professore, abbi pazienza » io lo supplico. « Prova a sentire… Non sarò mica io per caso a…? » Lui mi annusa col suo grande naso, sorridendo. « Tu sei su una brutta china, caro mio… Di questo passo finirai dritto manicomio. » « Professore, non inquietarti, l’odore c’è, ti giuro… E io ti sono amico… Io te lo devo dire… ascolta… non potrebbe darsi che… non potrebbe darsi a adorare di tartufo… insomma non potresti essere tu?». Il Tiriaca mi fissa, il sorriso gli si è fermato sulle labbra, non capisce se io voglio scherzare. Gli viene forse un dubbio? No. Si mette anzi a ridere di gusto. « Non mi illudevo che tu mi stimassi un luminare » dice « ma almeno che io non fossi un asino del tutto… Se mi fossi impestato, per capirlo credi forse che avrei bisogno dell’odore? Starei fresco… Altro che odore di tartufo… Sono i tuoi poveri nervi… »
Così lui parla, ma non serve. Per la prima volta io non gli credo, le sue parole non danno più sollievo. E intanto l’odore va crescendo, la casa ne è ammorbata, io cerco di andarmene al più presto.
No, in casa mia per fortuna non c’è il più vago ricordo di tartufi. Tuttavia stento a prender sonno. Quel pensiero mi tormenta. Se il Tiriaca fosse veramente contagiato? Se fossi stato io, l’ignorante, ad accorgermene? Poi mi dico: è impossibile, oltre all’odore ci sono molti altri indizi, lui li avrebbe subito avvertiti.
Anche la notte passa. Alle otto e mezzo salgo dal Tiriaca per accompagnarlo in clinica. Entrato, annuso. L’odore di tartufo non c’è più. Meno male, mi dico, si vede che era tutta suggestione. In quel mentre arriva il professore. << Beh, come la va? Senti ancora la presenza di tartufi? Ti sei calmato… Ieri sera dopo che te ne sei andato, non credere, io ci ho pensato su… e ho capito da dove ghe ghe quell’odore, in parte credo che sia… in parte… mah… invece, eh già… sgabusè toil gragiueaaa… » la frase si perse in un groviglio incomprensibile.
Arretrati, gelato dal terrore. Quello era il segno.
Tiriaca, che aveva avuto sempre la parola facilissima, barbugliava peggio di un demente.
Con una mano dietro la schiena avevo intanto girato la maniglia della porta, la spalancai di colpo, giù per le scale a precipizio. Non connettevo più dalla paura. Via subito, via da quella casa maledetta. Dall’alto il Tiriaca mi chiamò. Ma che mi importava più di lui?
La sera stessa fuggii dalla città. Adesso sono qui, con la famiglia, in questo paesello di montagna, che la peste ha dimenticato, si direbbe. E già è passato un mese. A quest’ora, se io fossi rimasto contagiato, il male sarebbe pur venuto fuori. Invece io sto bene, proprio bene, non emetto odori, parlo speditamente, vero che parlo con la massima scioltezza? Il brutto sarebbe infatti se all’improvviso cominciassi anch’io a barbugliare, confondendomi, allora si sippo po potrei dirmi spaccirmi… ma finché non si comincia a balbettare si può cocofon… allora sippo… chestra… sfiare… ir chiò… scimen… baorg… ge… ge…
Il tiranno malato
Che cosa li aveva sbaragliati quando già stavano assaporando il sangue : la Vittoria? Perché si ritiravano? ”Il mastino tornava a far loro paura:”
Non il mastino Tronk. Bensì una cosa informe e nuova che dentro di
lui si era formata e lentamente da lui stava espandendosi come un alone…infetto. . ……
I tre avevano intuito che a Tronk doveva “essere successo qualche cosa e non c’era più motivo di temerlo. Ma credevano di addentare un cane vivo.
E invece l’odore insolito del pelo, forse, del fiato, e il sangue dal sapore repellente, li aveva ributtati indietro. Perché le bestie più ancora che i luminari delle cliniche percepiscono ‘al più lieve segno l’avvicinarsi della, presenza maledetta, del contagio che non ha rimedio. E d.lottatore era segnato, non apparteneva più alla vita, da qualche profondità recondita del corpo già si propagava la dissoluzione delle cellule.
Dino Buzzati
Treccani Enciclopedia Online
Dino Buzzati, “Sessanta racconti” (1958)