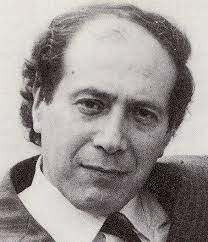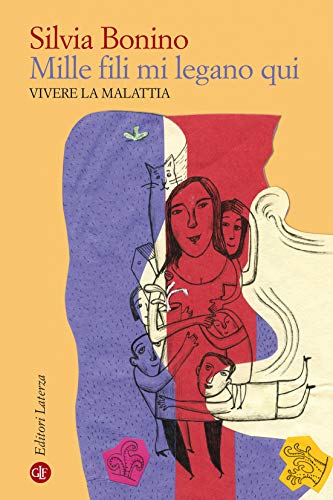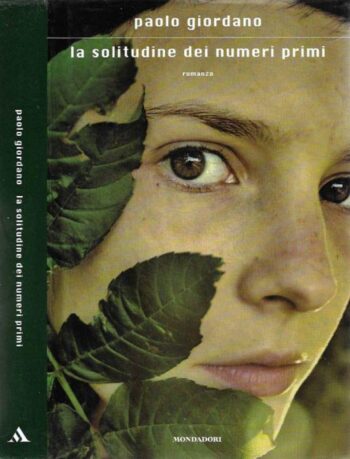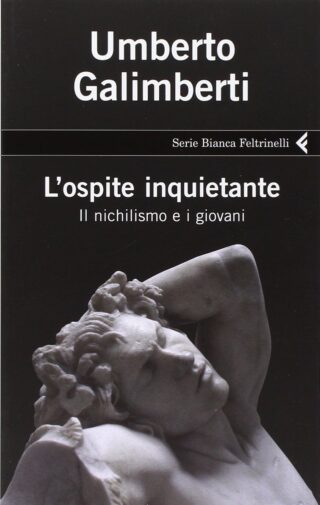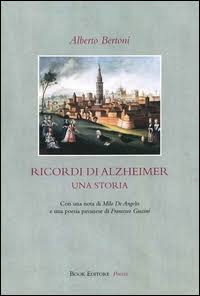Carmina
Il Liber di Catullo ha segnato una vera rivoluzione poetica nel I secolo avanti Cristo. Facente parte del gruppo dei νεότεροι (neoteroi), si lega in maniera strettissima alla poesia greca, portando con sé una raffinatezza poetica tipica dell’ellenismo. Le poesie che antologizziamo sono tra le più celebri della latinità: un amore, quello catulliano, profondo, paradossale, con vette di gioia, di amara assenza e sentita malinconia.
76.
Se per l’uomo che ritiene di essere devoto,
di non aver tradito la parola data, né giurato
in nome degli dei per ingannare la fiducia
nei rapporti umani, è fonte di gioia il ricordo
del bene compiuto; gli anni futuri ti riservano
molte gioie, Catullo, per questo amore ingrato.
Tutto il bene che a un essere umano è possibile
fare o dire, tu l’hai detto e fatto: e tutto
si è perduto nell’ingratitudine di un cuore.
Perché dunque continui a tormentarti?
e non cerchi con tutta la volontà di liberarti
di una infelicità che gli dei non vogliono?
Difficile troncare a un tratto un lungo amore,
difficile certo, ma in qualche modo devi riuscire.
È l’unica salvezza, quindi devi ottenerla:
che sia possibile o no, lo devi fare.
Se vi è pietà in voi, dei, se in punto di morte,
nell’ora estrema, recaste mai aiuto a qualcuno,
guardate la mia infelicità e se ho vissuto onestamente strappatemi da questo male che mi consuma,
che insinuatosi dentro di me nel piú profondo
come un torpore ha cancellato ogni gioia dal mio cuore. Non chiedo piú che lei ricambi il mio amore,
né l’impossibile, che mi rimanga fedele:
voglio solo guarire e scordarmi di questo male oscuro. O dei, per la mia devozione, accordatemi questo.
85.
Odio e amo. Me ne chiedi la ragione?
Non so, cosí accade e mi tormento.
Gaio Valerio Catullo
Fonte: catullo_le poesie