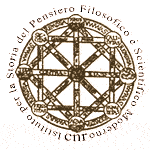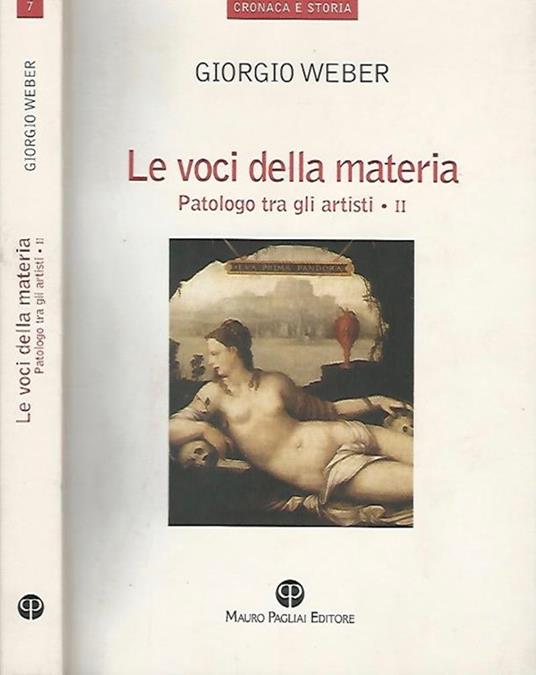Apocalisse. Vivere la catastrofe, immaginare il futuro
Durante la fase più acuta dell’epidemia da Covid-19, gli studiosi dell’Istituto per la storia del pensiero filosofico (Ispf) del Consiglio Nazionale delle ricerche ha riunito nello Speciale “Pandemia. Osservatorio filosofico” una serie di contributi di natura umanistica sul tema. Qui il ricercatore Roberto Evangelista ripercorre l’approccio al tema della crisi nella storia.
Nel corso della sua storia l’umanità ha sempre attraversato crisi enormi. Ricostruire la memoria della civiltà umana vuol dire probabilmente ricostruire il filo delle soluzioni trovate, di volta in volta, per risolvere la possibilità della fine.
Una umanità senza strumenti, chiusa in mondi piccoli e spesso autosufficienti (ma meglio sarebbe dire, autistici) si scontrava facilmente con momenti critici. Difficile, per esempio, era immaginare che il grano falciato ricrescesse; difficile era immaginare la certezza di una discendenza; complicato era gestire la demografia. E se complessa poteva essere la tenuta dei costumi morali di una comunità, impossibile doveva sembrare gestire catastrofi naturali o sconosciute malattie. Non dobbiamo andare troppo lontano, per immaginare cosa può aver significato per le popolazioni precolombiane l’incontro con virus e batteri sconosciuti e portati dai conquistatori.
Spinoza, all’inizio del suo Trattato teologico-politico ci ricorda che se l’uomo potesse con certezza governare gli eventi e gli sconvolgimenti della natura, non sarebbe soggetto ad alcuna superstizione. Questo è vero, ma non significa che la razionalità e la conoscenza della natura sono gli unici strumenti che possono metterci in uno stato di sicurezza. Certo, conoscere la natura aiuta a prevenirne le insidie, ma nel frattempo che la nostra conoscenza aumenta e aumentando si scontra con nuovi e inimmaginabili dubbi, l’umanità ha dovuto, per non abbandonarsi al delirio della superstizione, trovare strategie di reazione che compensassero quella mancanza di conoscenza. Se a questo aggiungiamo, poi, che la conoscenza e il completo governo della natura non li raggiungeremo mai, ecco che evidentemente alcune strategie, diciamo superstiziose, continuano a mantenersi attive e a compensare la nostra conoscenza parziale delle cose.
L’umanità ha trovato una strada per reagire alle crisi: raccontarsi storie. Non bugie, proprio storie, miti, favole. Storie di riscatto, oppure di sconfitta, storie nelle quali si prefiguravano i problemi e le soluzioni di una crisi. Storie nelle quali potevano essere proposte le diverse possibilità, i diversi destini umani, per provarsi a scegliere, a immaginare e magari a costruire un futuro. A questi racconti venivano spesso accompagnate ritualità di diverso genere: rappresentazioni o feste collettive, che rendevano quel racconto operativo, ovvero funzionale a stringere la comunità e interiorizzare un certo tipo di messaggio.
La funzione più importante dei miti non veniva assolta dal contenuto della storia che veniva raccontata. La funzione più importante del mito era il racconto stesso, e la sua condivisione. Italo Calvino, nella sua introduzione a Fiabe italiane, ci ricorda che le fiabe sono vere, perché contengono tutto il catalogo dei destini umani e delle possibilità. Percorrere insieme questo catalogo, però, non voleva dire avere semplicemente una maggiore cognizione di quello che poteva accadere, e prepararsi al peggio. Non importa quanto le favole venissero credute vere, o quanto ci fosse di “materialmente” vero nel loro contenuto; ciò che importava, era rafforzare e confermare il legame sociale, perché questa era l’unica risposta che si poteva dare in assenza di altri mezzi. E non era una risposta banale, né semplice, né tantomeno inefficace. È probabilmente questo tipo di risorsa che in un certo momento ci ha garantito la sopravvivenza: la facoltà di immaginare un futuro anche nei momenti più difficili.
Reagire a una crisi che mette in discussione la nostra presenza come genere umano, ci ha permesso di costruire edifici culturali che hanno fondato le comunità e le società umane. E questo, probabilmente, fa la differenza tra la nostra specie e le altre.
Ma da un certo momento in poi, cambiano molte cose: entrano nuove abitudini, e altre vengono svuotate di significato. D’altra parte, La nascita della famiglia, della società civile e dello Stato di Engels ci ha già permesso di riflettere su quanto il passaggio da una società comunitaria a una società divisa in classi abbia reso l’edificio culturale uno strumento di dominazione: il passaggio da una società matriarcale e comunitaria, a una società patriarcale e suddivisa in dominanti e dominati ha imposto una strutturazione dello Stato, con regole ferree a garanzia delle quali venivano posti sacerdoti o magistrati che amministravano la giustizia divina e umana, funzionale soprattutto a mantenere uno status quo non del tutto naturale.
Rimanendo, però, più ancorati al nostro tempo, ritroviamo, nei lavori principali di Ernesto De Martino (al quale queste righe sono fortemente debitrici) una inoppugnabile ricostruzione della resistenza di istituti culturali propri del mondo popolare e contadino, e del loro essere rivelatori di una posizione di subalternità di chi si trovava ai margini del “miracolo economico”. A fondamento di questo riferimento, c’è l’introduzione di un modo diverso di produzione che ha sconvolto i rapporti sociali. La fine della civiltà feudale e l’alba del mondo borghese ha significato la possibilità di una produzione su larga scala di beni essenziali che precedentemente venivano reperiti e fabbricati con molta difficoltà, e ha anche permesso la liberazione da alcune forme culturali che erano diventate una pesante zavorra, non solo per il nostro spirito.
La diversa organizzazione del lavoro produttivo ha significato un avanzamento scientifico, e questo ci ha permesso di prendere in considerazione l’ipotesi che le forze numinose che guidavano l’umanità produttrice di miti non ci avrebbero più salvato, perché questa incombenza spettava a noi (bisogna riconoscere, senza poter approfondire, che anche il cristianesimo ha avuto un ruolo in questo passaggio). La natura è diventata a mano a mano governabile, e allo stesso tempo gli dei e gli eroi dei miti sono caduti, si sono rivelati per essere solo proiezioni dell’essere umano. Si è avanzata la sottile percezione (non sempre, anzi quasi mai seguita da un atteggiamento coerente) che il peso del nostro destino fosse solo sulle nostre spalle. Ma questa consapevolezza, invece di arricchirci, ci ha in qualche modo impoverito. La distruzione delle vecchie certezze non ci ha permesso di crearne di nuove, e ci siamo trovati di fronte a due vicoli ciechi: ripercorrere le vecchie strade, oppure affidarci a una scienza anonima e senza volto.
Ma la scienza, da sola, non basta. Certo, la nostra vita è migliorata sotto molti aspetti. Ma questo miglioramento nella maggior parte dei casi è solo potenziale. L’uso che facciamo della scienza e della nostra capacità di governare gli eventi è del tutto sottostimato, tanto più che l’accesso al benessere che molte conquiste scientifiche rappresenterebbero è ben lontano dall’essere comune e condiviso. Questa “preclusione al progresso” ci getta in una condizione di miseria culturale, nella quale abbiamo abbandonato il vecchio modo di descrivere la realtà e di risolvere i conflitti comuni, ma non ne abbiamo trovato uno altrettanto efficace, o adeguato alle sfide che sono diventate probabilmente più complesse.
Lo capiamo meglio, se guardiamo a come abbiamo reagito alla pandemia da Coronavirus. Bisogna, per descrivere la nostra reazione, guardare alle immagini giuste. L’eccezionalità dell’evento che in poco tempo ci ha fatto precipitare in una condizione impensabile, ha prodotto un sovraccarico di significazione, per cui qualsiasi episodio, passaggio, parola, ha assunto o sembra assumere il valore di un simbolo. Proverò a fare una selezione di alcune immagini che ho trovato particolarmente significative.
La prima: gli scaffali dei supermercati pieni, a dispetto dei primi “assalti” alle provviste. La merce non manca, anzi per ora (tranne le mascherine e i disinfettanti per le mani) non sono spariti dal mercato i beni di prima necessità. Il problema, ma questa è storia vecchia, è che di merce ce n’è troppa rispetto a quella che si consuma, tanto che ogni giorno assistiamo alla distruzione di merci invendute. La nostra apocalisse si rappresenta così: l’impossibilità di consumare, o almeno di farlo ai ritmi precedenti. Il mercato online non ci soddisfa allo stesso modo, ma soprattutto abbiamo imparato a consumare in casa, in solitudine, togliendo alla valorizzazione della merce l’ultimo aspetto umano. La seconda: i senzatetto di Las Vegas, “parcheggiati” (letteralmente) negli spazi destinati ad automobili che invece si trovano al sicuro e al riparo dentro un garage. La terza (più che un’immagine, un racconto): una minuta domestica di Rio de Janeiro, che affronta un lungo viaggio per raggiungere il suo posto di lavoro. La famiglia presso la quale presta servizio, vuole che riprenda subito a lavorare nonostante loro siano tornati da un viaggio in Italia proprio nei giorni in cui sono emersi i primi casi di infezione da coronavirus. I suoi datori di lavoro hanno contratto il covid ma – potendo accedere a cure migliori – guariranno facilmente; la domestica, invece, ne morirà. La quarta: una donna ucraina che, per affermare la sua esistenza, inizia a urlare e si stende in strada. Abita a Napoli in zona “Fontanelle”, un quartiere molto popolare del centro storico, e da qualche giorno il marito lamenta i sintomi di una infezione da covid e aspetta invano che qualcuno venga a dare assistenza e a somministrare il tampone per determinare la positività al coronavirus. Questa immagine la trovo particolarmente significativa, perché ricorda le reazioni scomposte di fronte alle quali si trova Ernesto De Martino nei suoi viaggi nel meridione italiano, quando vede un mondo popolare letteralmente prigioniero di forme culturali del tutto fuori tempo, che provengono da un passato preindustriale, ma che non servono più a risolvere le crisi ricorrenti (lutti, magri raccolti, espropri e pignoramenti, epidemie di malaria etc.) di un mondo che evidentemente non aveva accesso ai “normali” standard di benessere. La ritualità arcaica che De Martino trova nelle comunità lucane e salentine, nella maggior parte dei casi, è priva di veri e propri riferimenti culturali e, più che una soluzione adottata da una comunità per ristabilire un legame sociale, assomiglia a un delirio privato o collettivo che riflette un disagio destinato a rimanere inespresso, perché si ritrova svuotata dei miti che ne accompagnano la ritualità.
Oggi, di fronte alla crisi, abbiamo pochi strumenti di riscatto, perché anche quelli della scienza risultano molto inefficaci. Se da una parte, non abbiamo strumenti culturali potenti (anche la religione in questo frangente sembra essere arretrata a uno strumento privato, e non ha invaso la sfera civile, come invece avvenuto in altri momenti storici), se siamo disposti a considerare più che plausibile l’inesistenza di forze divine a cui appellarci, se la scienza si è spesso sostituita al mito – assumendone alcune funzioni narrative, certamente -, dall’altra non siamo stati in grado di compensare questa “perdita”.
La realtà è che siamo arrivati a questa emergenza privi degli strumenti adeguati per risolverla, e questo basta a gettarci in una condizione di miseria culturale. Un terremoto, a prescindere dalla sua violenza, fa più danni se trova un territorio preparato alla catastrofe. Allo stesso modo, un virus che non ha una impressionante letalità, diventa una catastrofe generalizzata, perché trova una comunità che ha messo in secondo piano la solidarietà, l’investimento a fondo perduto nei servizi sanitari, e che ha creato tutte le condizioni materiali per soccombere a una disgrazia che di per sé non sarebbe stata catastrofica. Ma oltre a questo, l’avanzamento del progresso scientifico non si è accompagnato a una riorganizzazione dei rapporti sociali in senso stretto, anzi al contrario: è prevalsa l’illusione che l’automazione e il progresso potessero permettere a ciascuno “di fare da sé”. Abbiamo accettato (ma non poteva essere diversamente) di trasportare nella nostra vita quotidiana la condizione di individui assoluti, sciolti da ogni vincolo morale e sentimentale, che la civiltà borghese ha contribuito a spazzare via. Lo abbiamo accettato come società, ma questo non significa che lo abbiamo accettato tutti allo stesso modo (tentativi di controtendenza esistono, ma su questo diremo nelle conclusioni). Perdere il nostro legame sociale ha avuto un ruolo importante nel farci accettare le misure di confinamento come un provvedimento inevitabile (queste misure non nascono come necessarie, lo diventano sulla base di una situazione pregressa). Inoltre, lo sfilacciamento del legame sociale è la causa della nostra insicurezza ed è anche la ragione per la quale ci limitiamo ad affidarci a dati di dubbio valore: le curve epidemiche, i numeri dei morti, i guariti e i nuovi contagi, ci accompagnano ogni giorno e ci illudono di descrivere la realtà in maniera impeccabile, offrendoci la percezione di poter predire il futuro, un futuro che deve apparire vicino, e nel quale tutto tornerà come prima. Un futuro, insomma, davvero troppo vicino al nostro presente.
Ma pur senza gli antichi miti, pur senza l’antica ritualità, anche la nostra epoca si figura la sua fine, e lo fa in un modo del tutto peculiare: l’incapacità di consumare, la rinuncia alla qualità della vita sociale cui eravamo abituati, la fine della scuola, l’impossibilità di avere un sistema di cura sanitaria adeguato, il confinamento nelle case e la possibilità di uscire solo per lavorare e per produrre valore, sono gli spiragli attraverso cui guardiamo il collasso della nostra società. Possiamo benissimo immaginare di muoverci verso un mondo nel quale la didattica a distanza diventerà una normalità, nel quale il diritto all’apprendimento verrà negato a grosse fette di popolazione, nel quale saremo sempre più isolati nelle nostre abitazioni, e chi avrà il “privilegio” di uscire lo farà solo per andare in fabbrica; una versione grigia e oscura del capitalismo che assomiglia all’altra faccia della medaglia di cui abbiamo spesso parlato durante la nostra frenetica vita sociale; una versione “oscura” – oppure, chissà, quella più chiara e reale – del capitalismo che spesso si è affacciata ai nostri occhi di consumatori appassionati, ma che adesso sembra incombere sulla nostra testa come annuncio di un futuro probabile.
Questo scenario appare tanto più possibile, se ricordiamo, insieme a Marx, che il capitale ha un lato anarchico con cui disperde la sua mania di controllo e permette alle necessità e alle aspirazioni degli individui di svilupparsi, sebbene le lasci insoddisfatte. Infatti, se è capace di “produrre” tempo libero rendendo più alta la produttività del lavoro, deve lasciare che sia la classe dei proprietari a fruire di questa nuova libertà, a scapito di un’altra che invece assiste alla trasformazione del suo tempo di vita in tempo di lavoro[1].Si materializza un’apocalisse che non è la fine della nostra civiltà, ma ne è la fase suprema, la sua “iperrealizzazione”. Non sappiamo se questo avverrà per certo, ma lo vediamo e, anzi, l’impressione è che stiamo rimanendo fermi a contemplarlo. Non riusciamo a pensare un’alternativa, nemmeno come epilogo della nostra civiltà.
È più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo, scriveva Mark Fisher dieci anni fa. L’impossibilità di immaginare una fine a questo stato di cose, a rapporti sociali e produttivi così congeniati, è la vera e propria cifra ideologica della nostra epoca. Infine, il mito non è morto, e anche la nostra civiltà, anche il capitalismo, ha la sua mitologia, che non interpella nessun dio, ma descrive la perpetuazione di se stesso, il suo continuo perfezionamento, fino a sconvolgere gli stessi equilibri naturali pur di uscirne vittorioso, anche a scapito della stessa vita umana. Abbiamo decretato la morte delle ideologie, e con essa ci siamo condannati a una eterna ripetizione della nostra epoca. Nella visione dell’apocalisse che stiamo vivendo in questi giorni, non arriverà nessuno a salvarci, ma vivremo solo l’esasperazione delle contraddizioni di uno stato di cose che consciamente o inconsciamente ci siamo abituati a pensare come eterno o inevitabile. Il futuro che immaginiamo è davvero troppo vicino al nostro presente, non solo perché la logica dell’utilità impone di non andare troppo avanti nel tempo con l’immaginazione, ma anche perché difettiamo di quella fantasia che ci permettere di dipingere un affresco dei nostri possibili destini.
Naturalmente, questa percezione delle cose potrebbe risolversi in una di quelle “profezie autoavveranti”: con il nostro atteggiamento potremmo, cioè, favorire la trasformazione delle nostre vite in una certa direzione. Ma non possiamo ancora dire cosa succederà. Per fortuna.
La speculazione e la filosofia non ci aiutano a predire il futuro. E nemmeno i modelli matematici (casomai, le loro interpretazioni). Tuttavia capiamo facilmente che mai come adesso non possiamo rifugiarci nel There is no alternative, non possiamo adagiarci all’idea che tutto sarà come prima. Dobbiamo raccontarci una storia diversa. Abbiamo specificato, qualche riga sopra, che non tutti hanno accettato di allentare, di perdere una certa connessione sociale. Spesso le nostre scelte confliggono e resistono a un messaggio dominante che pure ci condiziona, ma che riusciamo a non accettare del tutto. Se così non fosse, non saremmo affezionati alla nostra sopravvivenza, non saremmo in grado di partecipare a iniziative e di mettere in campo azioni collettive che vanno in una direzione diversa.
Non dovrà tornare tutto come prima. Chiedere una sanità pubblica ed efficiente, pretendere anche in una condizione di questo tipo che i parchi restino aperti e che le fabbriche rimangano chiuse senza deroghe, spostare la centralità della nostra vita dal lavoro agli affetti, costruire reti di assistenza territoriali e pretenderne la regolarizzazione, relazionarsi agli altri Paesi in termini di comune e mutua solidarietà, e non in competizione (Cuba e Venezuela hanno mandato squadre di medici in Europa, mentre le nazioni occidentali cercavano di rastrellare le ultime scorte di mascherine rimaste sul mercato[2]), costruire una scuola che potenzi la sua funzione primaria, ovvero garantire il diritto all’apprendimento attraverso il contatto umano e attraverso l’educazione alle relazioni, sembrano cose piccole rispetto alle storie epiche di dei ed eroi; sono queste, però, le immagini reali e umane che prefigurano un futuro diverso, nel quale non saranno solo i ricchi a salvarsi, ma saremo ancora costretti a salvarci tutti insieme, nel quale la vita possa scorrere serena anche di fronte alle difficoltà, per come può farlo una vita a misura di un essere limitato e parziale come l’uomo, che nonostante tutto ancora non merita l’estinzione.
Roberto Evangelista, Cnr-Ispf
[1] «Date l’intensità e la forza produttiva del lavoro la parte della giornata lavorativa sociale necessaria per la produzione materiale sarà tanto più breve, e la parte di tempo conquistata alla libera attività culturale e sociale degli individui sarà tanto maggiore, quanto più il lavoro sarà distribuito proporzionalmente tra tutti i membri della società capaci di lavorare e quanto meno uno strato della società potrà allontanare da sé la necessità di natura del lavoro e addossarla ad un altro strato. Il limite assoluto della riduzione della giornata lavorativa è sotto questo aspetto l’obbligo generale del lavoro. Nella società capitalistica si produce tempo libero per una classe trasformando in tempo di lavoro l’intera vita delle masse». K. Marx, Il Capitale, Roma, 1970, libro I, sezione V, capitolo XV.
[2] Non sono state le uniche iniziative internazionali di solidarietà, ma sono state quelle più importanti e significative, soprattutto considerando la campagna diffamatoria che colpisce questi Paesi.
Il contributo sulle pagine “Pan/démia Osservatorio Filosofico” del Cnr-Ispf