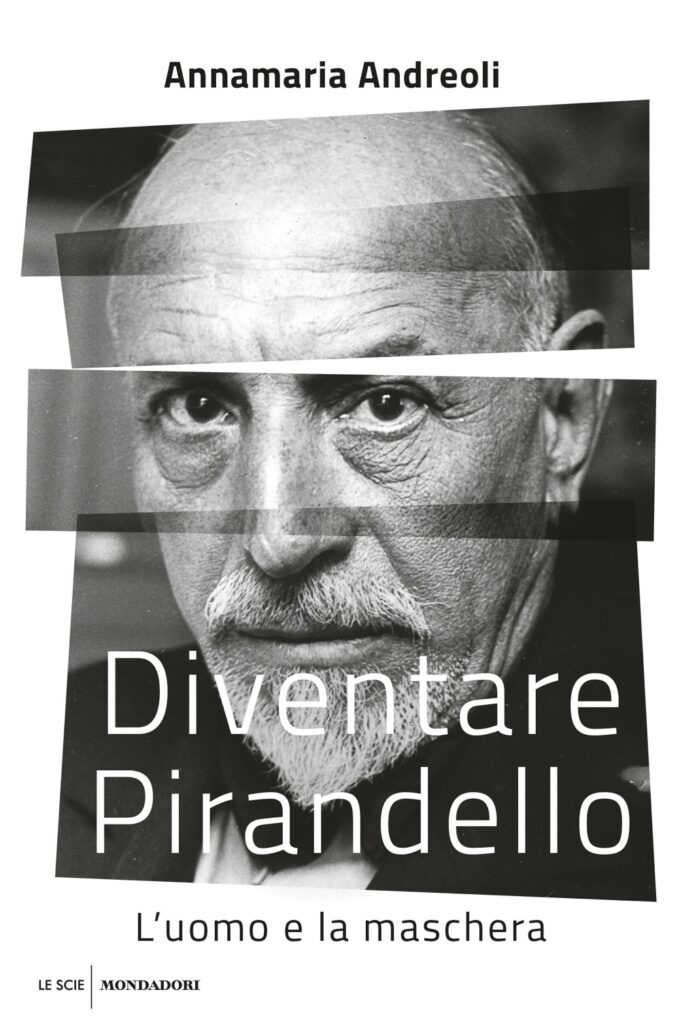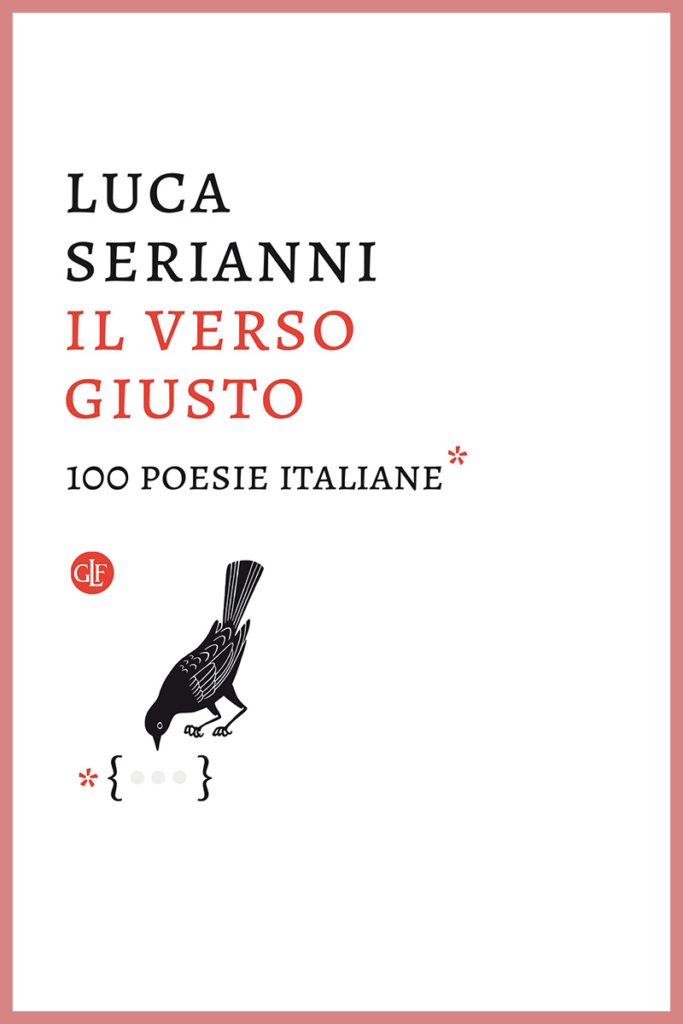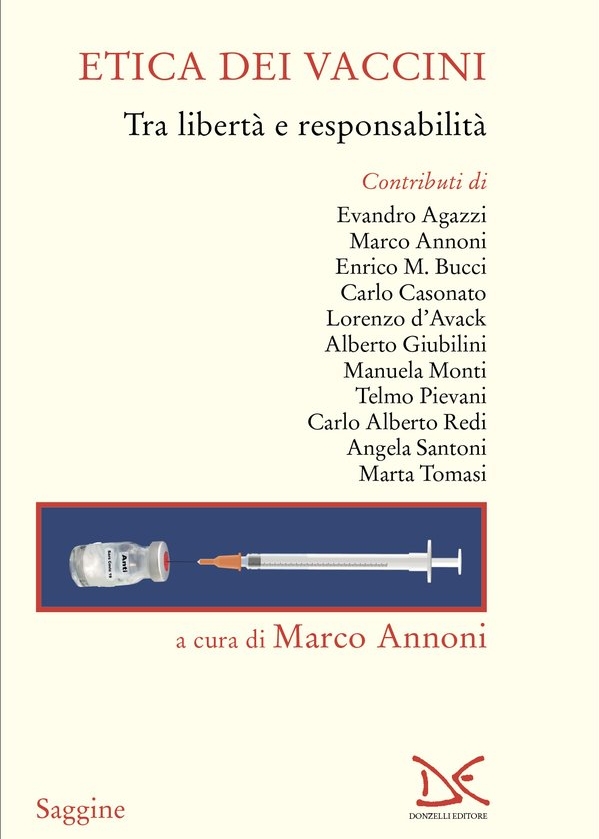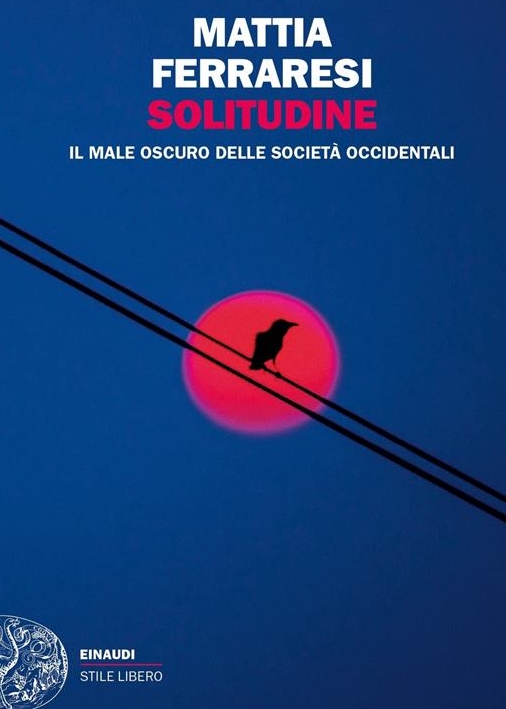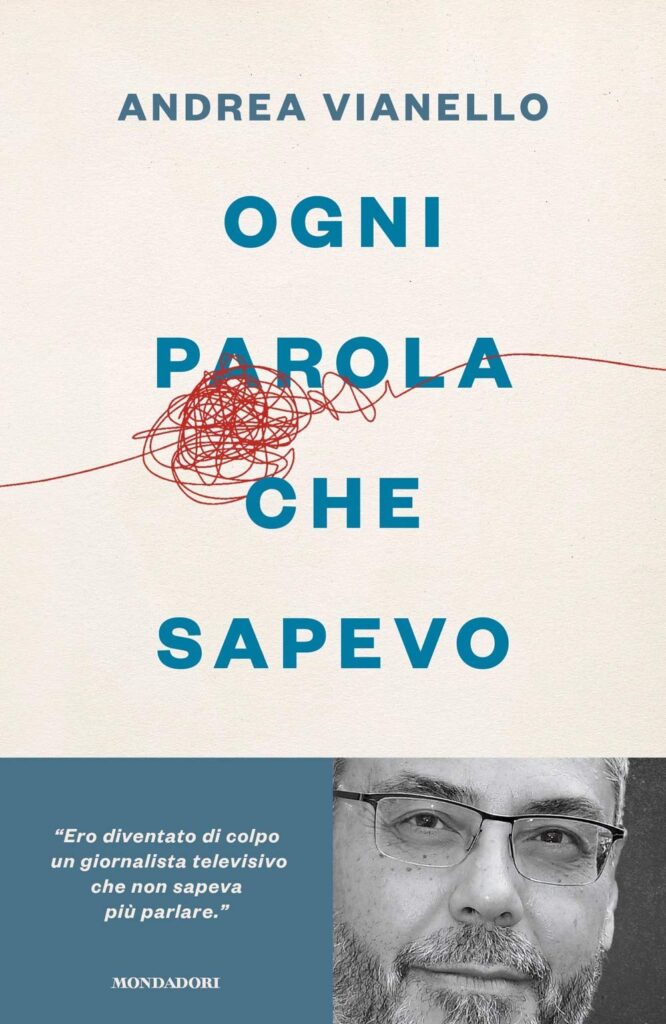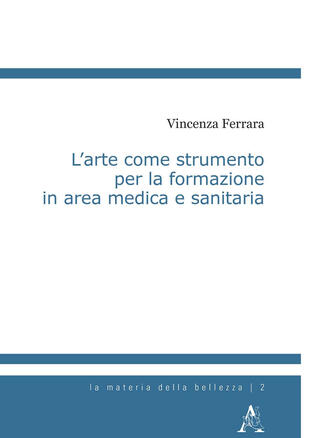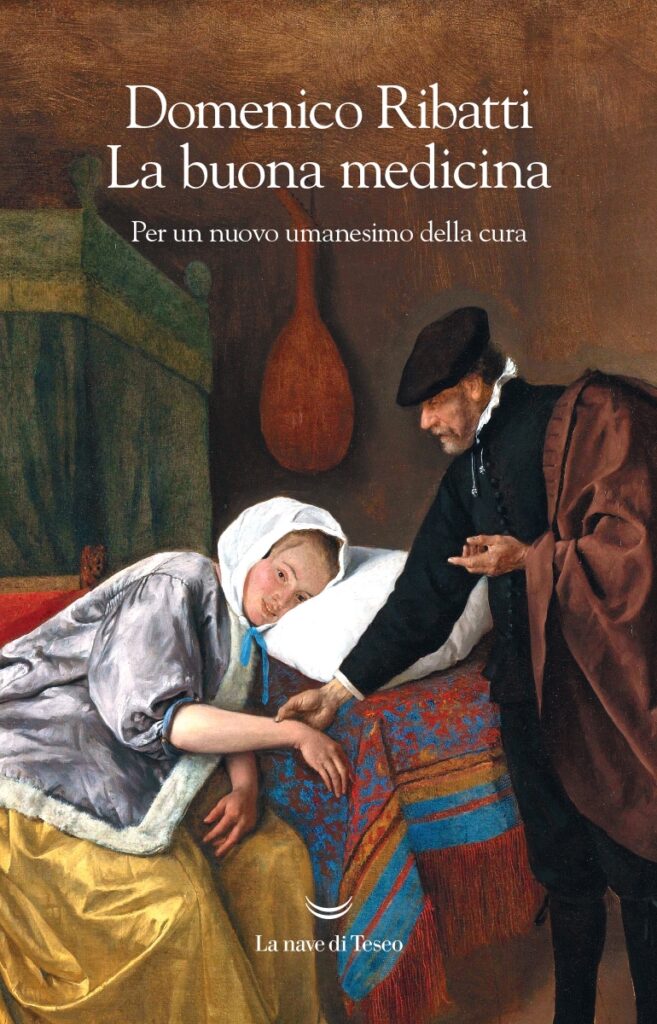Simone Cristicchi, il ricercautore

Di esperienze, tra cui quelle sanremesi, ne ha collezionate molte. Abbina collaborazioni, ispirazioni e modalità sempre nuove, dalla canzone al “teatro civile”, dalla musica ai libri, dai video ai fumetti: il suo primo maestro è stato Jacovitti. Temi centrali: la poesia, la follia, la memoria storica
Si è svolto di recente un Sanremo anomalo, unico, per la mancanza di pubblico e la carenza di ospiti dovute alla pandemia, che si sono riflesse anche in un pesante calo di ascolti. In passato, però, il Festival è stato l’occasione per la scoperta, il rilancio o l’esplosione di molti artisti italiani: tra questi, Simone Cristicchi, che di esperienze sanremesi ne ha collezionate diverse. In particolare nel 2007 quando, con “Ti regalerò una rosa”, ha vinto il Festival e i premi della Critica e Radio Tv, aggiungendoci un disco d’oro e un tour con più di 100 eventi live. Difficile comunque ricordarne tutti i riconoscimenti, dai premi Gaber ed Endrigo al Cilindro d’argento dedicato a Rino Gaetano; e poi la Targa Tenco, i premi Musicultura, Mogol, Giancarlo Bigazzi, Anna Magnani, Tomizza, Dante musica e parole (assegnato dall’Accademia della Crusca), Amnesty Italia, Nassiriya per la pace, la cittadinanza onoraria di Trieste. A colpire di questo artista è soprattutto l’eclettismo, che lo porta ad abbinare collaborazioni, ispirazioni e modalità espressive sempre diverse, tra cui quella del “teatro civile” legato a temi sociali e storici spinosi. “In tutte le mie esperienze – spiega – ho però cercato di portare un tratto di originalità: ogni allievo, a un certo punto, deve recidere il nastro che lo lega al maestro. È stato questo il più grande insegnamento che ho ricevuto da Jacovitti”.
Partiamo da questa sua origine artistica, che forse non tutti conoscono
Sono stato sin da piccolo un appassionato di disegno e fumetto e Jacovitti, all’epoca in cui i miei coetanei stravedevano per Silvester Stallone, Rambo e Rocky, era lui il mio idolo. Così sono stato suo allievo. Quando andai a imparare da lui conobbi da un lato un uomo burbero, come lo immaginavo, dall’altro una figura tenera, quasi paterna. Agli inizi mi limitavo a imitarlo come una fotocopiatrice umana, lui mi rimproverò ma mi prese sotto la sua ala protettrice con grande pazienza.
Tempo dopo sono arrivati il teatro civile, o “teatro canzone”
L’innamoramento per questa forma d’arte straordinaria, un’invenzione tutta italiana. Di Giorgio Gaber mi colpì particolare la capacità, con le sue invettive inarrivabili, di non distaccarsi mai dai fatti storici. Ma ricordiamo anche Ascanio Celestini, il “Vajont” di Marco Paolini. E poi Gigi Proietti: lo vidi e teatro quando avevo 16 anni, stette tre ore da solo sul palco, uno sforzo incredibile, davvero “uno contro tutti”. Nella mia formazione e ispirazione ha avuto un ruolo importante anche mio nonno, che era un grande narratore. Il mio è un percorso con molte tappe, fino a un certo punto fatto solo di musica e concerti, poi ho avvertito il bisogno di misurarmi con il monologo, che è stato un po’ come cimentarmi nelle Olimpiadi, considerando che non ho mai frequentato una scuola di teatro.
Si è cimentato anche con temi storici non sempre “pacificati”: come mai in Italia fatichiamo a condividere la nostra memoria?
Io credo che la memoria condivisa sia possibile, la parte che la rifiuta è una minoranza infinitesimale. Chi ha criticato “Magazzino 18”, il musical che ho dedicato al dramma delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, appartiene a un’area estremistica. Inizialmente ho provato a dialogare con queste persone poi, quando la contestazione si è fatta più dura, come per una rappresentazione a Scandicci, ho capito che non era possibile. In quell’occasione mi sono sentito sia imbarazzato per loro sia divertito, visto che così hanno dato allo spettacolo una pubblicità enorme, che ha contribuito a realizzare 300 repliche sold out.
A proposito di memoria dolorosa, è stato anche direttore artistico del Teatro dell’Aquila. Che ricordo ne porta?
Durante l’incarico ho avvertito la responsabilità di rappresentare una città sofferente, ancora in piena rinascita e ricostruzione, con una ferita non rimarginata. Io ho provato a farla vedere da un’altra prospettiva, producendo con il Teatro Stabile d’Abruzzo lo spettacolo “Manuale di volo per uomo”. Una favola in musica e poesia su un quarantenne bambino, che trova stupefacente qualunque cosa guardi e che non sappiamo se considerare un “ritardato” o un genio. Io lo definisco un “super-sensibile”, capace di mettere a fuoco particolari che nascondono un’infinita bellezza, apparentemente insignificanti ma che non dovremmo lasciarci sfuggire.
Un tema, quello delle sensibilità sbrigativamente classificate come malattia mentale, che torna in molte sue opere. Come mai?
Il mio mondo è stato molto abitato dalla malattia mentale, io stesso ho camminato sul filo della follia. Ero bambino quando morì mio padre e quel dolore mi spinse al rifiuto della realtà: per anni mi sono rinchiuso nella mia stanza, creando un mondo tutto mio, di fantasia, fumetti, poesia, un mondo perfetto in cui nulla poteva ferirmi. Poi arrivò l’interesse per i “matti” del quartiere dove vivevo. Ho avuto anche un amico con problemi di dipendenza che finì in ospedale per un Tso, il Trattamento sanitario obbligatorio: andando a trovarlo scoprii una realtà che ignoravo completamente, quella dei “nuovi” manicomi.
Per lei è diventata una sorta di battaglia civile.
Lo stigma del malato di mente resta irraccontabile, ma io cerco di rappresentare le storie di queste persone dimenticate, abbandonate in un reparto: con la mia piccola telecamera sono stato nel manicomio calabrese di Girifalco, ho realizzato un viaggio per gli ospedali psichiatrici d’Italia. Sono nati così opere come “I matti de Roma”, “Centro di igiene mentale”, che racconta la mia esperienza di servizio civile, l’album e il documentario “Dall’altra parte del cancello” e, naturalmente, “Ti regalerò una rosa”.
La sofferenza dell’attuale pandemia, il lockdown e la riduzione dei contatti sociali non le ricordano un po’ quell’isolamento?
Per noi artisti questo è stato un trauma reale. A me sono state cancellate all’improvviso 60 date, un danno economico enorme, personale e per il mio staff. Ma ho cercato comunque di prendere questo evento come un regalo: da una vita estremamente movimentata mi sono ritrovato a vivere in campagna, a contatto con me stesso, con il tempo di pensare e di scrivere un album e un libro, “Abbi cura di me”. In attesa di tornare a percorrere la mia strada.
Quali altre tappe prevede?
Molte, tra cui “Happy next – Alla ricerca della felicità”, uno spettacolo e documentario con canzoni, racconti e video che considero una priorità, la condivisione di una mia scoperta. Attraverso la voce di personaggi dello spettacolo e della cultura, e di gente comune, cerco di rispondere alla domanda che tutti ci poniamo: che cosa è veramente la felicità?
La definizione di “ricercautore” le si adatta bene.
Mi considero una sorta di rigattiere, di antiquario, continuo a scandagliare la memoria storica ma anche una geografia sconosciuta, un mondo interiore invisibile.
Alla ricerca scientifica in senso stretto è interessato?
Molto. Sono curioso e affascinato soprattutto dalla ricerca che coniuga scienza e spiritualità, come la fisica quantistica. Quelle connessioni che Ervin Laszlo racconta in “Risacralizzare il cosmo”.
Lei unisce il registro ironico di “Vorrei cantare come Biagio”, brano che l’ha lanciata nel 2005, con quello serio. In questo ricorda Sergio Endrigo, con cui ha realizzato il duetto “Questo è amore” e di cui ha cantato una versione di “Io che amo solo te”
Nella mia vita privata come pubblica non c’è nulla di progettuale, cerco di fare in modo che l’artista e l’uomo coincidano. Endrigo, è stato un artista equivocato, oltre che una parte del mio percorso. “Biagio” fu un brano di grande successo ma poi il tempo taglia le cose, fa affiorare l’anima autentica dell’artista che, nel mio caso, è quella emersa con “Ti regalerò una rosa”. A un certo punto ho capito che l’artista deve avere un ruolo preciso nella società, un compito, una visione. Non tornerei più a parlare di cose relativamente futili e la corda popolare dell’ironia può descrivermi solo in parte. Ora per me è importante la parola, la poesia.
Marco Ferrazzoli
Lettere dal Manicomio
Ti regalerò una rosa