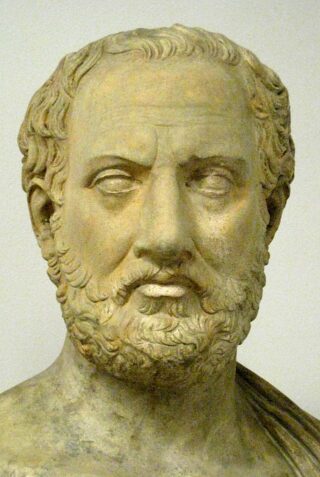Il brano antologizzato è tratto dalle ultime pagine dell’Agamennone di Eschilo, una tragedia greca rappresentata nel 458 a.C, insieme ad altre due tragedie (che, insieme con la prima, compongono la trilogia dell’Orestea) e ad un dramma satiresco. Cassandra ha previsto la morte propria e del re “pastore dei popoli” Agamennone per mano della regina Clitemnestra (o Clitennestra), con la complicità dell’amante Egisto. La morte dei due si consuma fuori scena, secondo la consuetudine del teatro tragico attico.
CASSANDRA
Ahi, ahi, la fiamma, eccola! Mi assale! Apollo Liceo, a me, a me! Leonessa a due gambe, a letto col lupo, mentre il leone gagliardo è lontano. Lei mi abbatterà: ah, mio tormento. Come preparando filtro di morte, mischierà alla vendetta la mia parte di paga. Affila la lama per lui, il suo uomo. La morte – di questo si vanta – sarà giusto compenso per avermi condotta sin qui. Perché vi ho ancora indosso, scettro, fasce profetiche sulle spalle? Perché si rida di me? Vi spezzo, io stessa prima dell’ora fatale. Distrutte vi voglio. Nella polvere, ecco come io vi ripago. Un’altra al mio posto fate ricca di strazio. Guardate, la mano stessa di Apollo mi strappa il velo oracolare. Prima posava l’occhio superbo su me che così abbigliata ero esposta alle beffe di tutti: amici, nemici, perfetto equilibrio di scherno… “E mi adattavo al nome ormai consueto: Ciarlatana!” rifiuto umano, in giro ad accattare, miserabile morta di fame. Per finire, il mago che m’ha fatta maga, lui m’ha trascinata a questa vicenda di morte. Non l’altare – nella casa paterna – ma il tronco del boia mi aspetta, scarlatto di tiepido sangue dal mio capo reciso. Cadremo, ma non senza castigo di mano divina. Sarà qui uno a vendicare, germoglio matricida, esigerà il saldo per l’assassinio del padre. Lui, fuggitivo, cacciato lontano in esilio, è ormai di ritorno: pronto a incorniciare con l’ultimo fregio l’avito edificio di colpe. Saldo patto hanno giurato gli dèi. Lo spingerà il gesto implorante del padre steso al suolo. Perché questo abisso di pianto? Ho forse pietà di me stessa? Ho visto, all’inizio, compiersi il fato di Troia. Ho visto i suoi vincitori uscire in questo stato dal divino giudizio. Perciò mi avvio, voglio il mio destino: patire la morte! Cassandra volge lo sguardo al portale del palazzo. E ora a te, mia porta dell’Ade: ti saluto. Mi tocchi un colpo preciso, lo supplico. Senza scarti d’agonia – fiotti, torrenti di sangue per una morte soave. Così possa chiudere gli occhi.
CORO
Quanto devi patire, donna di alto sapere! Hai detto molto. Ma se realmente conosci la tua fine fatale, perché questo strano coraggio, questi passi verso l’altare, come vittima rapita dal dio?
CASSANDRA
No, ospiti, non c’è salvezza neppure tardando.
CORO
È impagabile l’ultimo istante.
CASSANDRA
La mia ora è qui: fuggendo guadagno ben poco.
CORO
Attingi coraggio dal tuo animo prode. Sappilo.
CASSANDRA
Chi ha sorte felice non ode simili frasi.
CORO
Una morte illustre affascina gli uomini.
CASSANDRA
O padre! Te, e i tuoi nobili figli!
CORO
Cos’hai? Quale spavento ti strappa indietro?
CASSANDRA
Ahimè!
CORO
Perché questo “ahimè”? Brivido d’orrore, dentro?
CASSANDRA
Sfiata assassinio la casa, gronda cruenta.
CORO
Come può? È aroma di offerte votive, dai focolari.
CASSANDRA
Si distingue come un respiro di tomba.
CORO
Non c’è incenso d’Oriente là dentro, a tuo dire!
CASSANDRA
Parto. Ululerò ai trapassati il mio fato e quello di Agamennone. Sia finita qui. Ah stranieri! Grido: non di spavento – uccello a un’ombra di fronda – ma perché di tutto questo, dopo la fine, mi siate testi fedeli, nell’ora che una donna, a saldare la mia morte di donna, cadrà, e un uomo dovrà morire, in cambio di un uomo cui fu fatale la sposa. Pensate che sto per morire. Fatemi questo dono ospitale.
CORO
O tu che soffri, ho pena del fato che tu stessa t’annunci.
CASSANDRA
Ancora una volta voglio dire parole distese, non cantilene di lutto, per la mia morte. Davanti a quest’ultima luce di sole, io chiedo ai vendicatori del re che facciano scontare ai nemici anche la mia uccisione, di me morta schiava, vittima disarmata. Vicende terrene! Prospere, e basta un’ombra a travolgerle: se la sorte è ostile, una passata di spugna stillante, e il disegno è perduto. Questo mi fa piangere, molto più di tutto il resto. Cassandra entra nella reggia.
CORO
Hanno nel sangue gli uomini
fame implacabile di felicità.
Nessuno di quelli che la gente
già mostra col dito, vuole
vietarle l’entrata, scacciarla
dal proprio palazzo, gridando
“Non avvicinarti, mai più.”
A quest’uomo i beati donarono
di vincere la terra di Priamo,
e torna alla patria
pieno di onori divini.
Ma ora, se deve saldare il sangue
di chi l’ha preceduto,
se per quelle morti antiche
morendo lui stesso compie
espiazione di altri assassinii,
quale uomo, che sappia la storia,
può dire di essere nato
all’ombra di un destino innocente?
Dall’interno della reggia, laceranti, esplodono voci di dolore.
AGAMENNONE
Aaah! Ho dentro, m’inchioda colpo preciso.
CORO
Silenzio. Chi grida, trapassato da colpo preciso?
AGAMENNONE
Altra fitta, orrenda! Due colpi ho in corpo.
CORO
L’azione è conclusa: quest’ululo del re me lo fa sospettare. Amici, scambiamoci i pareri sicuri. Vi dico quel che penso: far gridare in città che si corra alla rocca.
Per me, scattare subito dentro, smascherare il delitto con evidenza di lama appena estratta. Ecco il mio voto, su cosa decidere: mi associo a questo consiglio. Non è ora d’indugi.
Apriamo gli occhi. Queste sono le prime battute, indizi di tirannide, di ciò che stanno preparando allo stato. Troppo tardi: loro schiacciano sotto i piedi il decantato “pensaci bene”! Intanto la mano è ben sveglia. Non so quale miglior consiglio dare: l’agire esige riflessione attenta, …
Sono dalla stessa parte: non ho il mezzo di far risorgere l’ucciso a parole.
Dunque, salvare la vita. E per questo, chinarsi ai padroni che sono infamia alla casa?
No, non si può tollerarlo. Meglio la morte, è più dolce che subire i tiranni.
Come indizio c’è l’urlo del re. Ci basta per crederlo ucciso?
Vediamoci chiaro, poi venga pure lo sdegno. Indovinare, ed essere certi: c’è differenza.
Per me, prevale questo parere, e l’approvo: sapere con certezza la fine dell’Atride.
Lento, si spalanca il portale della reggia. Dentro, tre figure. Riverso in una conca lucente, avvolto in un largo drappo chiazzato di sangue, il corpo di Agamennone. Accanto, abbattuta, Cassandra. Li sovrasta – l’arma è ancora in mano – Clitennestra, superba.
CLITENNESTRA
In passato molte parole ho detto sfruttando un’occasione: ora, non avrò scupoli a smentirle. Come può, uno, tramando ostili colpi a gente ostile che si presenta con la faccia amica, gettare rete di sventura, altezza che nessun balzo varca? Da troppo tempo non mi usciva dalla mente questa gara di morte. Ora il premio della lotta, la vittoria: tardi, ma alla fine è giunta! Qui mi ergo, dove vibrai l’arma, dove ho saldato il mio impegno. Ho agito, ho avuto successo, non voglio celarlo: né scampo per lui, né riparo al colpo fatale. Un volo di rete, inestricabile – come a una mattanza – e lo ingabbio, sfarzo doloroso di stoffe. Io due squarci. Due rantoli, lui, fascio di membra snervate, lì al suolo. È steso. Un terzo colpo gli assesto. Grato ossequio a Zeus dell’abisso, patrono dei morti. Sfoga l’anima crollando – una boccata precipitosa di sangue e spira. Mi schizza di fosche stille – velo di rugiada scarlatta che mi fa lieta, come la semente del grano, quando nel pieno sbocciare dei chicchi s’ingemma del rorido dono del cielo. Questi gli eventi, degna nobiltà di Argo. Esultate se vi piace. Io me ne glorio. Se mai fosse buon momento per libare su un ucciso, ora sarebbe giusto, legittimo, anzi. Quest’uomo ha colmato il calice di troppi crimini, qui nella reggia: al suo ritorno gli è toccato svuotarlo.
CORO
Ci scuote la tua lingua sfacciata, questa voce superba contro lo sposo.
CLITENNESTRA
Mi state saggiando: quella donna insensata, pensate. Io però con cuore immoto mi rivolgo a gente che intende. Tu mi assecondi, sei disposto? Mi critichi? È lo stesso. Ecco Agamennone, sì mio marito. Morto. Colpo di questa abile mano, autrice di vendetta. Questi i fatti.
CORO
str. I
Regina, che tossico frutto della zolla
inghiottisti, che filtro stillato
dall’onda salmastra
per commettere l’assassinio?
Per spezzare, troncare
l’imprecazione che sale dal paese?
Sarai fuorilegge, sotto un carico d’astio
ti schiaccerà la tua gente.
CLITENNESTRA
Adesso tocca a me fuggire il paese, affrontare l’astio, la pubblica esecrazione: così tu ora sentenzi. Non facesti contrasto in passato a quest’uomo. Lui, senza scrupolo – non conta la morte di un’agnella, quando il pascolo trabocca di mandrie ricciute – immolò la sua figlia, frutto doloroso e adorato del mio parto. Doveva affascinare, in Tracia, il calo di vento. A lui no, non toccava l’espulsione da questo paese, a fargli scontare il crimine osceno. Alle mie azioni, invece, tendi le orecchie, e ti fai giudice senza pietà. Ora ascolta. Limita le minacce, potrai darmi ordini, ma solo piegandomi con le tue mani: io, per me, sono pronta, da pari a pari. Régolati. Certo, se dio decide l’opposto, apprenderai la dura lezione di un tardivo equilibrio di mente.
CORO
ant. I
Sei spavalda di cuore
e alzi la voce arrogante.
Delira il tuo spirito
per il cruento colpo di fortuna.
Ombra fosca di sangue
– la vedo – ti scintilla negli occhi.
Hai vuoto d’amore, intorno:
devi espiare il colpo con colpo di risarcimento.
CLITENNESTRA
E tu considera la santa base dei miei giuramenti: su Equità che rese giustizia a mia figlia, su Perdizione punitrice divina, su Erinni, cui dedico quest’uomo scannato, mai varcherà la mia soglia il brivido della paura, finché attizzi il fuoco nel mio braciere Egisto, pieno d’affetto, come sempre in passato, per me. È lui scudo non piccolo del mio franco ardire. Eccolo, steso, colui che schizzò fango su questa donna, l’incanto delle Criseidi, laggiù sotto Troia. E guarda, ecco la preda di guerra, la veggente, la profetessa d’oracoli che spartì il letto con lui. Che amica fedele di letto, ora, guardali! Come quando si stendevano insieme sul ponte delle navi! Non è salato il conto, di quei due. Lui, giace così come vedi. Lei, modulò la nenia estrema dell’agonia – un cigno, pareva. Eccola stesa con lui, a fare l’amore. Me la porse lui, il mio uomo, ghiotto contorno al mio godere!
Eschilo
Fonte: eschilo_agamennone