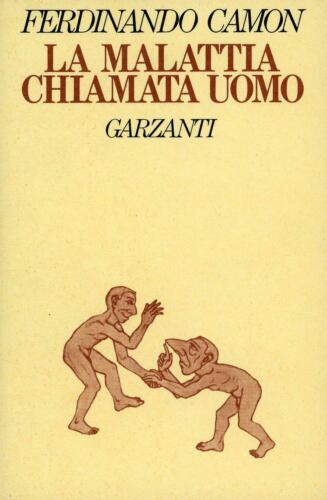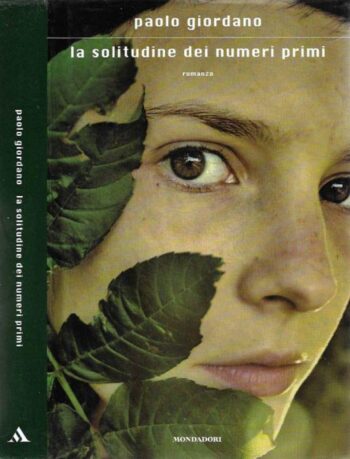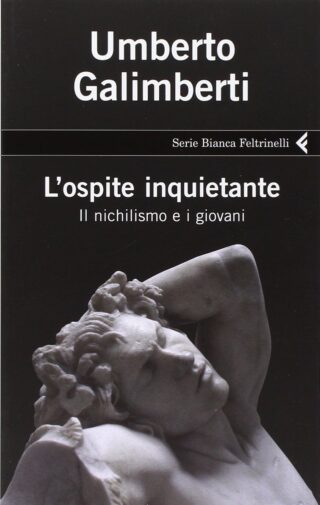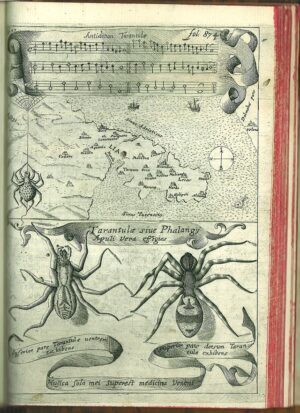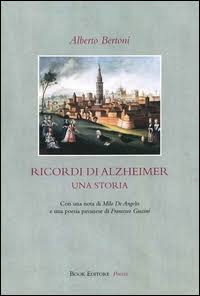In viaggio con Camon nella psicanalisi ‘ideologica’
Un romanzo che rappresenta un viaggio nell’inconscio di un uomo, attraverso il racconto del suo percorso clinico di analisi, e al tempo stesso fornisce una testimonianza storica e culturale della fine del ‘900.
Garzanti descrive “La malattia chiamata uomo”, in questa nuova edizione, come ‘la storia, forse raccontata per la prima volta dall’interno, di un’analisi’. Una presentazione forse eccessiva, solo che si pensi intanto a “La coscienza di Zeno” e soprattutto all’insuperato, per il coinvolgimento quasi empatico del lettore, “Le parole per dirlo” di Marie Cardinal. Detto ciò, l’operazione editoriale resta quanto mai opportuna: il romanzo di Ferdinando Camon uscito nel 1981, tre anni dopo quel “Un altare per la madre” che gli valse il premio Strega, non accusa il tempo ma anzi si afferma come una sorta di documento storico. Sia dal punto di vista narrativo, ad esempio nei riferimenti alla valuta in lire o nella descrizione dei viaggi notturni in treno, sia soprattutto nelle descrizioni delle esperienze di analisi intraprese.
Il romanzo è un ‘viaggio nell’inconscio di un uomo, fin là dov’è sconosciuto anche a se stesso e alle sue donne’, che si snoda per tappe penose e irritanti insieme, surreali e soggettive quanto concrete e reali. C’è il terapeuta autorevole che fuma incessantemente durante la seduta, del quale si avvertono effluvi e gorgoglii gastrico-intestinali e che, alla fine, non rilascia la ricevuta per l’intero importo, ridendo apertamente della propria afferenza al popolo degli evasori fiscali. Non manca il guru carismatico che maltratta i suoi pazienti, con plateali quanto soggettive discriminazioni, in uno sconcertante rapporto stoccolmiano.
Si tratta certo di figure che appartengono a un’analisi molto legata a quell’epoca fortemente ideologizzata, in senso sia freudiano sia politico. Oggi Camon, riscrivendo il libro, probabilmente tratteggerebbe i nuovi terapeuti ‘light’, i consulenti improvvisati, i taumaturghi pret-à-porter, ma al fondo resta la medesima, importante problematica di una professione dalle delicatissime implicazioni, spesso affrontata con molta prosopopea e scarsa professionalità. È fornendoci quest’importante spunto di riflessione che “La malattia chiamata uomo” dimostra la sua attualità. Confermata da alcune considerazioni dell’autore che mantengono intatta la loro validità: ‘La sostituzione del cuore naturale con un cuore artificiale’, scrive Camon, ‘questo è l’evento più grave della nostra storia negli ultimi decenni. Il fatto che nessun giornale lo nota, e tutti parlano di altri mali, è come se, al capezzale di un infartuato, i medici si preoccupassero anzitutto delle sue emorroidi’. Come suol dirsi, sembra scritta ieri.
Marco Ferrazzoli
Ferdinando Camon, “La malattia chiamata uomo” (Garzanti, 2008)
https://www.garzanti.it/libri/ferdinando-camon-la-malattia-chiamata-uomo-9788811683568/