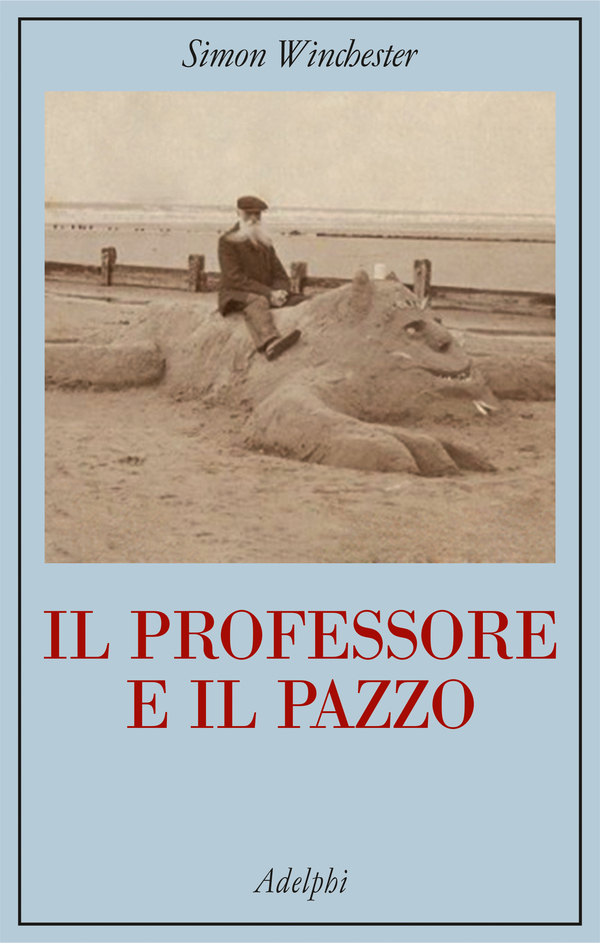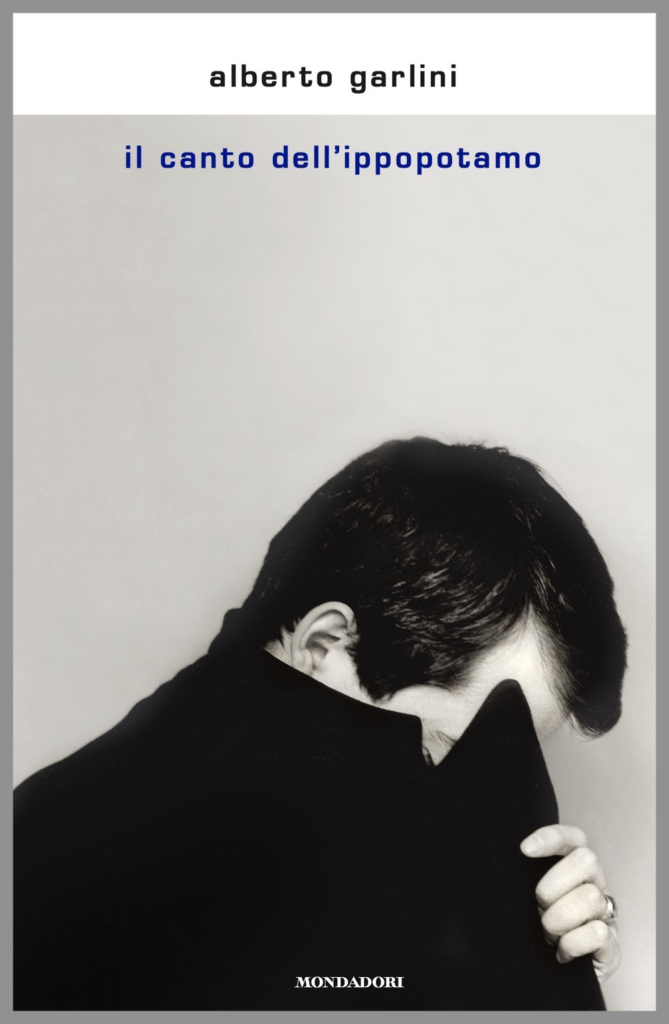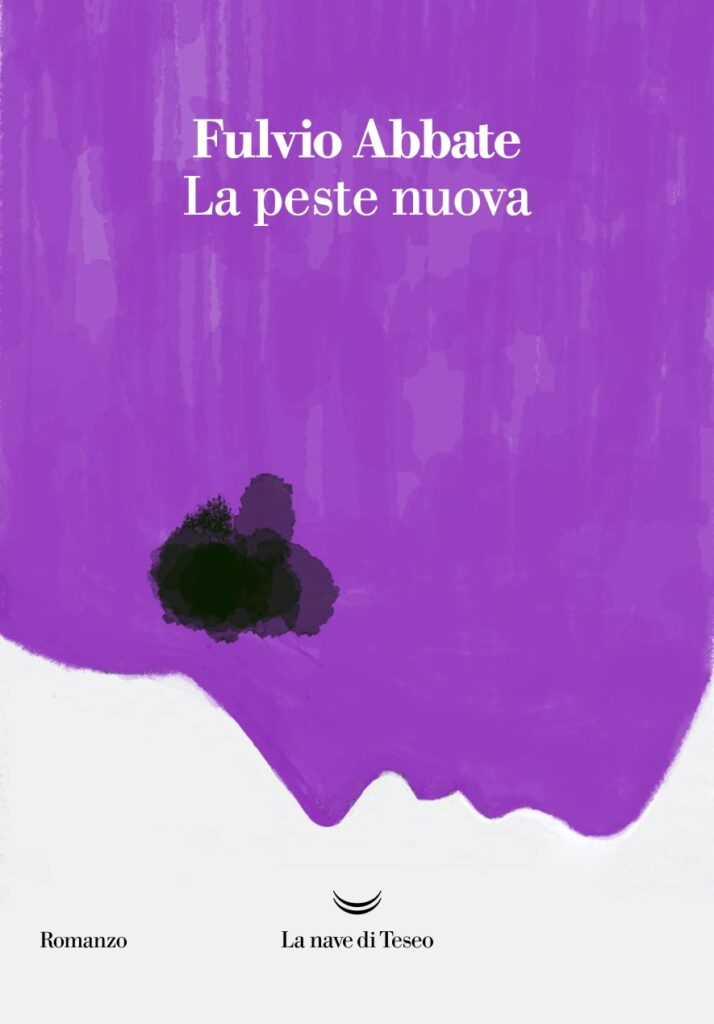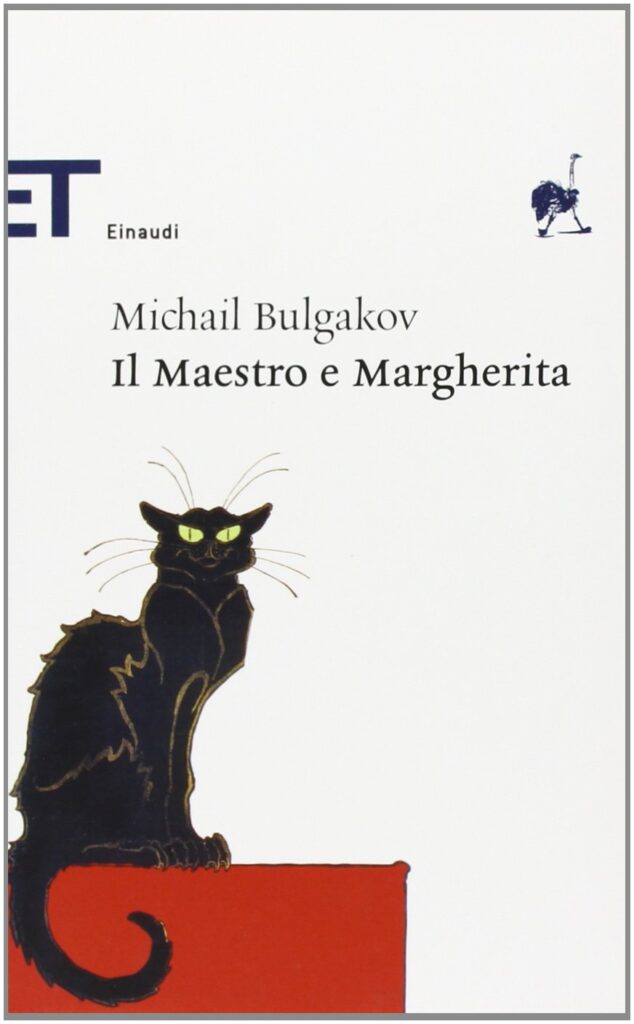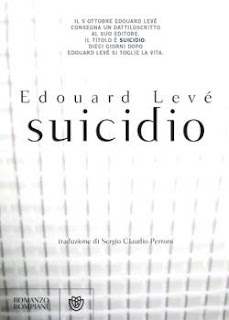Batteri e virus, una guerra. Contro la paura
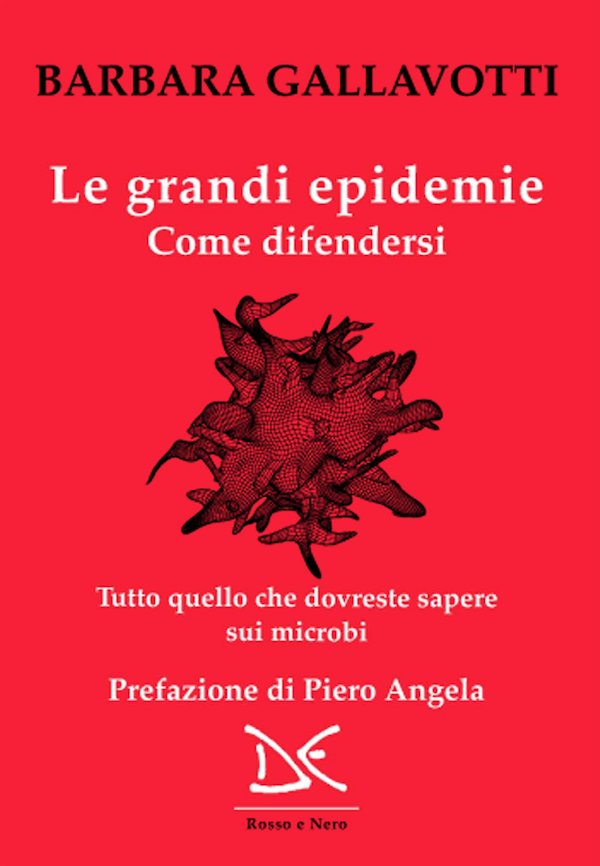
‘Le grandi epidemie’ di Barbara Gallavotti evidenzia come gli agenti infettivi siano stati capaci di uccidere più uomini di qualsiasi armata sulla Terra e si chiede: “Chi vincerà alla fine?”. La risposta è che uno dei principali alleati di questi nostri temibili e minuscoli avversari è il sentimento irrazionale che porta da un lato a diffidare dei vaccini e dall’altro ad assumere con leggerezza gli antibiotici. Mentre il corretto uso di queste innovazioni è la migliore arma a nostra disposizione
La letteratura divulgativa su virus, batteri, microbi, vettori e agenti patogeni è amplissima. Solo per citare randomicamente alcuni titoli degli ultimi lustri, va da ‘Epidemie’ di Giovanni Rezza a ‘Pillola del giorno prima. Vaccini, epidemie, catastrofi, paure e verità’ di Marco Malvaldi e Roberto Vacca; da ‘Batteri spazzini e virus che curano’ e ‘Occhio ai virus’ del nostro Giovanni Maga a testi opportunamente rivolti ai lettori più giovani come ‘Le difese del mio corpo’ di Laurent Degos e ‘Virus, microbi e vaccini’ di Clara Frontali; da monografie su specifiche patologie come ‘Aids. Breve storia di una malattia che ha cambiato il mondo’ di Cristiana Pulcinelli a ‘Metafisica della peste’ di Sandro Givone. Il tema delle patologie epidemiche e infettive è poi protagonista di saggi fondamentali come ‘Quarto cavaliere – Storia di epidemie, pestilenze e virus’ di Andrew Nikiforuk e ‘Armi, acciaio e malattie’ di Jared Diamond.
Quest’ultimo titolo, in particolare, è citato nella bibliografia dell’ultimo arrivato in questa cospicua e importante galleria saggistica: ‘Le grandi epidemie’ di Barbara Gallavotti, per il quale la giornalista di Superquark ha preso spunto da un’intervista di Francesco Maria Galassi, professore di Paleopatologia alla Flinders University in Australia e che si arricchisce di un’introduzione in cui Piero Angela evidenzia come i microrganismi siano “stati capaci di uccidere più uomini di qualsiasi armata sulla Terra”, nonostante (o forse proprio perché) siano “nostri parenti”, addirittura “i nostri più lontani progenitori”. I batteri sono stati infatti “i primi ad arrivare sulla Terra e saranno con ogni probabilità gli ultimi ad andarsene”, affermazione con cui il nostro massimo divulgatore focalizza la questione centrale del libro: “Chi vincerà alla fine l’eterna guerra fra gli esseri umani e gli agenti infettivi?”, si chiede Gallavotti in conclusione del volume. Rispondendo che, comunque, “non abbasseremo mai la guardia” e avvertendo che uno dei principali alleati di questi nostri avversari temibili e minuscoli (i batteri misurano millesimi di millimetro e i virus sono molto più piccoli) è la paura, il sentimento che “spinse i genovesi a lasciare precipitosamente Caffa e altri ad abbandonare le città appestate nel tentativo di sfuggire a un morbo che in realtà portarono con loro”. E che in tempi più recenti “ha indotto il governo del Sudafrica per diversi anni a sposare tesi negazioniste riguardo all’Hiv come causa dell’Aids”, che temendo gli untori “in innumerevoli casi” non ha fatto che produrre altre vittime innocenti, che sospetta dei migranti come ambasciatori di nuove o vecchie malattie.
Ma le paure forse più attuali e rischiose sono quelle, in qualche modo opposte, che ci portano da un lato a diffidare dei vaccini e dall’altro ad “assumere con leggerezza farmaci inappropriati, ad esempio antibiotici”. Se “Tutta la storia dell’umanità è stata una lunga battaglia contro i microbi responsabili delle malattie infettive”, che però abbiamo “combattuto per decine di migliaia di anni solo con gli strumenti messi a disposizione dall’evoluzione”, infatti, fortunatamente “negli ultimi decenni abbiamo messo a punto strumenti in grado di proteggerci dalle infezioni”, cioè vaccini e antibiotici. Influenza, morbillo, vaiolo, tifo, colera, sifilide hanno sterminato generazioni, compiuto genocidi, sin dai tempi raccontati da Tucidide, passando per il contatto tra europei e popolazioni amerindie, hanno cambiato il corso della storia, colpendo personaggi come Cesare Borgia, William Shakespeare e Friedrich Nietzsche. Ancora tra il 1918 e il 1919 l’influenza spagnola provocò tra 50 e 100 milioni di morti, più della contestuale guerra mondiale. E nel Novecento il vaiolo, prima di essere definitivamente sconfitto, ha causato 300-500 milioni di vittime…
Ma oggi abbiamo due tipi di farmaci fondamentali, “i vaccini, capaci addirittura di prevenire le malattie, e gli antibiotici, in grado di contrastare le principali infezioni batteriche”. Peccato che “i vaccini rischiano di essere resi inefficaci dalla decisione di alcuni di non servirsene e gli antibiotici da quella di usarli male”. Certo, virus e batteri hanno una straordinaria capacità di sviluppare ceppi resistenti, quella che combattiamo è “una rincorsa tra ricercatori e germi patogeni”, avverte cauto Angela. Ma per sperare di vincerla dobbiamo usare le armi che abbiamo in modo adeguato e convinto. Senza paura (per non usare altri termini).
Marco Ferrazzoli
Barbara Gallavotti, “Le grandi epidemie” (Donzelli, 2019)
Fonte: Almanacco CNR – Recensioni