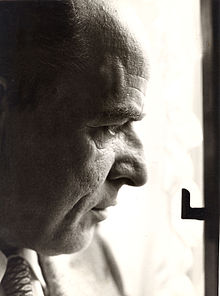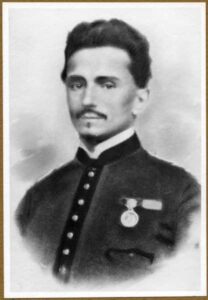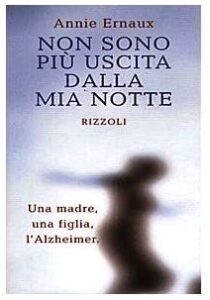I tempi odierni tengono in noi ben viva la percezione della difficoltà di gestire i pazienti afflitti da malattie contagiose. Medesimo problema, in condizioni notevolmente ridotte, si presenta a monsignor Bienvenu nel XIX secolo. Ma monsignor Bienvenu stupisce ogni lettore con un atto di amore davvero incredibile.
Il palazzo vescovile di D. era attiguo all’ospedale. Era un vasto e bell’edificio in pietra, costruito all’inizio del secolo scorso da monsignor Henri Puget, dottore in teologia della facoltà di Parigi, abate di Simore e, nel 1712, vescovo di D. Quel palazzo era una vera e propria dimora principesca. Tutto vi aveva un aspetto maestoso: gli appartamenti del vescovo, i saloni, la corte d’onore, vasta, con porticato secondo l’antica moda fiorentina, i giardini, folti di magnifici alberi. Nella sala da pranzo, una lunga e splendida galleria situata al pianterreno e che si apriva sui giardini, monsignor Henri Puget aveva offerto, il 29 luglio 1714, un pranzo ufficiale ai monsignori Charles Brûlart di Genlis, arcivescovo principe di Embru, Antoine de Mesgrigny, cappuccino, vescovo di Grasse, Philippe de Vendôme, gran priore di Francia, abate di St-Honoré de Lérins, François de Berton de Crillon, vescovo barone di Vence, César de Sabran de Forcalquier, vescovo signore di Glandève e Jean Soanen, prete dell’oratorio; i ritratti di questi sette reverendi personaggi ornavano quella sala, e la data memorabile, 29 luglio 1714, era scolpita a lettere d’oro su una lapide di marmo bianco. L’ospedale era una casa stretta e bassa, a un sol piano, con un giardinetto. Tre giorni dopo il suo arrivo il vescovo visitò l’ospedale. Terminata la visita fece dire al direttore di voler essere così gentile da raggiungerlo a casa sua. «Quanti malati avete ora, signor direttore dell’ospedale?».
«Ventisei, monsignore».
«Proprio quanti ne avevo contati».
«I letti sono un po’ addossati l’uno all’altro», soggiunse il direttore.
«Proprio quello che avevo notato».
«Le corsie non sono che stanze ed è difficile cambiar l’aria».
«Mi sembrava».
«E poi, quando c’è un raggio di sole, il giardino è troppo angusto per i convalescenti».
«È proprio quello che mi stavo dicendo».
«Nelle epidemie (quest’anno, per esempio, abbiamo avuto il tifo; due anni fa la miliare) cento ammalati a volte, e non si sa come provvedere».
«Proprio quello che pensavo».
«Che volete, monsignore, bisogna rassegnarsi!», disse il direttore.
Questa conversazione avveniva nella sala da pranzo-galleria; al pianterreno. Il vescovo rimase silenzioso un poco, poi si volse bruscamente verso il direttore dell’ospedale:
«Signore, quanti letti credete possano stare in questa sala?».
«La sala da pranzo di monsignore?», esclamò il direttore sorpreso.
Il vescovo percorreva la sala con lo sguardo, quasi facesse con gli occhi calcoli e misure.
«Almeno venti letti!», disse come parlando a se stesso, poi, alzando la voce:
«Sentite, signor direttore, di certo c’è un errore. Voi siete ventisei persone in cinque o sei camerette. Noi qui, in tre, abbiamo posto per sessanta… ci dev’essere uno sbaglio, vi dico, voi occupate casa mia e io la vostra. Rendetemi la mia casa. È questa la vostra».
Il giorno dopo i ventisei poveri ammalati venivano sistemati nel palazzo del vescovo e il vescovo era all’ospedale. Monsignor Myriel non possedeva nulla, la sua famiglia era stata rovinata dalla Rivoluzione. Sua sorella godeva di una rendita vitalizia di cinquecento franchi che, al presbiterio, bastava solo alle sue spese personali. Myriel percepiva dallo Stato, come vescovo, un appannaggio di quindicimila franchi. Il giorno stesso in cui andò ad abitare all’ospedale, monsignor Myriel stabilì, una volta per sempre, d’impiegare tale somma nel modo seguente. Copiamo una nota scritta di suo pugno.
Victor Hugo