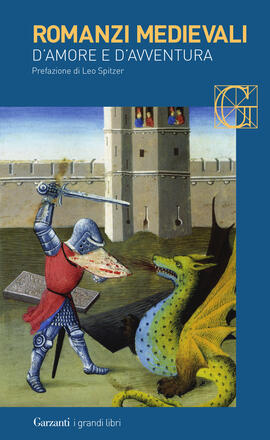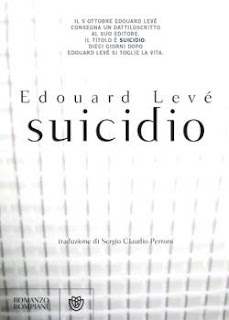Il testo è tratto dal “romanzo” di Apuleio Le Metamorfosi o L’Asino d’Oro, che tratta delle avventure cui deve andare incontro il protagonista del libro, Lucio, trasformato in asino per la propria stolta curiosità. L’Asino Lucio nel suo vagare incontra esempi di grande virtù e di bassissima scelleratezza, che l’autore dipinge con tinte fosche. Il brano antologizzato rappresenta uno di questi ultimi casi: Lucio si trova ad assistere ad un caso di omicidio.
X. II
Alcuni giorni dopo, ricordo che si scoprì proprio lì un delitto orribile, un crimine efferato, di cui voglio accennarvi in questo mio libro perché possiate conoscerlo anche voi.
Il padrone di casa aveva un figlio, molto istruito e per questo modesto e virtuoso, tanto che anche tu, lettore, avresti gradito averne uno come lui.
La madre era morta da molto tempo e il padre s’era risposato e da questo secondo matrimonio aveva avuto un figliolo che allora poteva contare dodici anni.
Ma la matrigna che nella casa del marito si faceva notare più per la sua bellezza che per i buoni costumi, o perché lei era corrotta per natura o perché il destino la spingeva all’infamia più degradante, certo è che mise gli occhi sul figliastro.
Bada bene, lettore, io sto raccontandoti di una tragedia non di una commediola e che quindi dal socco ora si passa al coturno.
La donna, finché l’amore era sul nascere e quindi poco esigente, seppe resistere ai suoi deboli stimoli e soffocare facilmente in silenzio la tenue passione; ma quando il crudele iddio cominciò a divamparle in cuore e a diffondere come una smania per le sue intime fibre, ella cedette, e, fingendo un mortale languore nascose la ferita dell’animo dando ad intendere d’esser malata.
Tutti sanno che il deperimento del volto è comune agli ammalati come agli innamorati: viso pallido, occhi languidi, gambe fiacche, sonni inquieti, respiro sempre più affannoso, via via che cresce la pena.
A vederla pareva che lei si agitasse soltanto per un attacco di febbre e, invece, piangeva anche. E quanta ignoranza nei medici: cosa volevano dire il polso frequente, le vampe al viso, il respiro ansimante, il continuo voltarsi e rivoltarsi ora su un fianco ora sull’altro?
Santo cielo! Com’è facile capire, anche senza essere un medico, cosa vuol dire quando uno brucia e non ha
febbre, solo se si ha un po’ d’esperienza nelle cose d’amore.
III
La donna, dunque, nella sua eccitazione, non riuscendo più oltre a contenersi, decise di rompere il lungo silenzio e mandò a chiamare il figlio, nome questo che, se avesse potuto, per non arrossire, se lo sarebbe volentieri cancellato dalla mente.
Il giovane non indugiò a obbedire all’ordine della matrigna ammalata e con la fronte segnata dalla tristezza e dal cruccio, come quella di un vecchio, con tutto il dovuto rispetto entrò nella camera della moglie di suo padre e della madre di suo fratello.
La donna, però, depressa dal lungo tormentoso silenzio, fu ripresa dai dubbi e le parole che un momento prima aveva ritenute adatte per la circostanza, ora le sembravano sconvenienti e, trattenuta da un senso di vergogna, non sapeva da dove cominciare.
E quando il giovane, non sospettando di nulla, le chiese con deferenza che male avesse, lei, approfittando che, malauguratamente, erano soli, divenne audace e scoppiando in un pianto dirotto, coprendosi il volto con un lembo della veste, con voce trepidante, così gli parlò brevemente: «Tu sei la causa, l’origine del mio male, ma tu sei anche il rimedio, la mia sola salvezza. I tuoi occhi, fissando i miei, mi son penetrati dentro fin nel profondo dell’animo e vi hanno acceso un fuoco che mi brucia tutta e che non riesco più a estinguere. Muoviti a pietà d’una donna che muore di te e non farti scrupolo per tuo padre a cui, in fondo, salvi la moglie che altrimenti morrebbe. Del resto io ti amo anche perché nel tuo volto ritrovo il suo. Non aver timore, siamo soli e c’è tutto il tempo per far quello che ormai è inevitabile; e poi, le cose che non si vengono a sapere è come se non fossero mai accadute.»
IV
Il giovane rimase sconvolto da quella inattesa rivelazione e sebbene fosse inorridito dinanzi a un crimine così mostruoso, pensò di non esasperare la donna con un netto rifiuto ma di calmarla con vaghe promesse e, intanto, di prender tempo.
Così le dette tutte le assicurazioni possibili e immaginabili, le disse di tirarsi su, di rimettersi in salute e di attendere che suo padre si assentasse per qualche viaggio perché allora essi si sarebbero goduti a loro agio.
Così le disse e subito si sottrasse alla insidiosa presenza della matrigna e andò difilato a trovare il suo maestro, un vecchio di molta esperienza e di gran senno, pensando che in una così grave sciagura familiare fosse urgente un qualche saggio consiglio.
I due ragionarono a lungo e insieme convennero che l’unico rimedio era quello di sottrarsi con la fuga alla tempesta che il destino avverso addensava su quella casa.
Ma la donna che non ce la faceva più ad aspettare, con un pretesto qualsiasi e con straordinaria abilità riuscì a convincere il marito a recarsi subito in certe sue proprietà molto distanti di lì. Fatto questo, ancor più eccitata perché vedeva appagata in anticipo la sua speranza, pretese che il ragazzo, come le aveva promesso, si concedesse alla sua libidine.
Ma il giovane, ora con una scusa ora con un’altra, cercò di eludere l’infame convegno, tanto che la donna comprendendo chiaramente da tutti quei pretesti che egli non aveva alcuna intenzione di mantenere la sua promessa, con estrema volubilità, mutò il suo nefando amore in un odio ben più terribile. E chiamato un suo schiavo che s’era portato in dote, uno scellerato capace di tutti i delitti, lo mise a parte delle sue criminali intenzioni, e a entrambi non parve cosa migliore che uccidere lo sventurato ragazzo.
Così la matrigna mandò subito quel delinquente a procurarsi un veleno a effetto istantaneo che, accuratamcnte sciolto nel vino, doveva togliere di mezzo il figliastro innocente.
V
Mentre quei due criminali s’accordavano sul momento più opportuno per dargli da bere il veleno, il ragazzo più giovane, proprio il figlio di quella perfida donna, rientrò a casa dalle lezioni del mattino e, fatta colazione e sentendo sete, vide quel bicchiere di vino in cui era stato messo il veleno e, non sospettando quale insidia nascondesse, bevve tutto d’un fiato.
Così il ragazzo bevve la morte destinata al fratello e, di schianto, crollò esanime a terra.
Accorse sgomenta tutta la servitù e la stessa madre alle grida del maestro sconvolto da quella repentina tragedia, e subito apparve chiaro che si trattava di veleno e ognuno cominciò a fare le più svariate supposizioni sugli autori di quell’orribile delitto.
Ma quella femmina perversa, esempio più che unico della malvagità delle matrigne, non fu punto turbata dalla morte improvvisa del figlio, non sentì alcun rimorso per quel delitto, per la sventura della sua famiglia, per il dolore del marito, per il lutto che avrebbe avvolto la casa, ma trasse spunto da questa disgrazia per portare a compimento la sua vendetta.
Inviò subito un corriere per informare della sciagura il marito che era in viaggio e, quando questi rientrò a precipizio, con un’audacia senza pari, disse che era stato il figliastro ad assassinare con il veleno suo figlio. E in questo, se vogliamo, mentiva fino a un certo punto, perché, in effetti, il ragazzo aveva rivolto su di sé la morte destinata all’altro; epperò aggiunse che il fratello minore era stato ammazzato dal figliastro perché lei non s’era concessa alle sporche voglie di quest’ultimo che aveva tentato di farle violenza.
Inoltre, ancora non contenta di queste turpi menzogne, aggiunse che quando s’era visto smascherato, l’aveva minacciata con la spada.
Sgomento per la perdita dei suoi due figli il povero padre si sentì come travolto da un’immane catastrofe.
Il figlio più piccolo se lo vedeva infatti seppellire sotto i suoi occhi e l’altro sapeva che glielo avrebbero condannato a morte per incesto e omicidio. Eppure verso quest’ultimo, per le false lacrime di una moglie troppo amata, sentiva ormai un odio profondo.
VI
S’erano appena concluse con la sepoltura le cerimonie funebri che il povero vecchio con il viso ancora scavato dal pianto e i capelli bianchi sporchi di cenere, lasciò il sepolcro del figlio e raggiunse il tribunale. Qui, fra le lacrime e le implorazioni, gettandosi ai piedi dei decurioni, ignaro delle frodi della perfida moglie, scongiurò con tutta l’anima che l’altro suo figlio fosse condannato a morte, dichiarandolo colpevole di incesto per aver violato il talamo paterno, un fratricida per l’uccisione del fratello, un assassino per aver minacciato di morte la matrigna.
E tanta fu la pietà, tanto lo sdegno che egli suscitò nei senatori e fra il popolo che di fronte ad accuse così schiaccianti e palesi e a prove così deboli e incerte portate a sua difesa, tutti gridarono che bisognasse tagliar corto con le lungaggini procedurali e che quel pericolo pubblico fosse condannato pubblicamente alla lapidazione.
Ma i magistrati temendo di esporsi a un rischio troppo grande se da un banale motivo di sdegno il tumulto popolare avesse preso dimensioni tali da minacciare lo stesso ordine cittadino, da un verso si raccomandarono ai decurioni, dall’altro convinsero il popolo perché si istruisse un processo secondo tutte le regole della procedura nel rispettò della tradizione, si esaminassero le prove portate dall’una e dall’altra parte e si pronunziasse una sentenza regolare, non all’uso dei barbari o dei selvaggi o come fanno i tiranni e i prepotenti che condannano un cittadino senza nemmeno ascoltarlo; questo anche per non dare, in un’età di prosperità e di pace, un esempio di crudeltà.
VII
Quando ciascuno si fu seduto al posto che gli assegnava il suo rango, nuovamente il banditore si fece sentire e chiamò il primo accusatore, poi, a gran voce, anche l’imputato, mentre avvertiva gli avvocati, secondo la legge Attica e la procedura dell’Areopago a non dilungarsi in esordi e a non appellarsi alla pietà popolare.
Che le cose fossero andate così io lo seppi dopo da alcune persone che continuarono a parlarne; quale poi sia stata la requisitoria del pubblico accusatore e con quali argomenti l’imputato si sia difeso e poi le arringhe e le discussioni, io non so proprio, confinato com’ero nella stalla, e quindi non sono in grado di riferirvelo; perciò su queste carte riporterò soltanto quello che ho potuto accertare.
Dunque, terminati i dibattiti, fu deciso che la verità e l’attendibilità delle accuse fossero accertate da prove sicure per non giungere a una condanna così grave su semplici sospetti e che, quindi, era necessario far venire in tribunale quel famoso servo, il solo che a detta di tutti, sapeva com’erano andate effettivamente le cose.
Ma quel delinquente, per nulla turbato dall’esito incerto di un processo così importante, né dalla maestà della curia riunita al completo e tanto meno dalla sua coscienza sporca, cominciò a raccontare un sacco di fandonie facendole passare per pura verità, che cioè quel giovane, infuriato per la repulsa della matrigna, lo aveva chiamato e per vendicarsi gli aveva chiesto di uccidere il figlio della donna promettendogli un grosso premio in cambio del suo silenzio; e che siccome lui s’era rifiutato, lo aveva minacciato di morte; che gli aveva consegnato il veleno da far bere al fratello, preparato con le sue mani, ma che poi, sospettando che egli non compisse il delitto e si tenesse la tazza come prova, alla fine l’aveva porta al ragazzo lui stesso.
Con queste dichiarazioni che quel miserabile fece con un’aria tutta spaventata e come se dicesse le cose più vere di questo mondo, il processo ebbe termine.
Questo saggio consiglio venne accolto e subito il banditore ebbe l’incarico di radunare i senatori nella curia.
VIII
Fra i decurioni non vi fu più nessuno disposto alla benevolenza. Di fronte all’evidenza tutti ritennero di dover proclamare il giovane colpevole e degno di essere cucito nel sacco.
La sentenza fu unanime ed era già stata trascritta sulle schede che ciascuno si apprestava a metter nell’urna di bronzo secondo la consuetudine di sempre, dove, una volta deposte, avrebbero irrevocabilmente segnato la sorte del reo e rimesso la sua testa al carnefice, quando un senatore, uno dei più anziani, stimato da tutti per la sua rettitudine e medico di grande prestigio, coprendo con la mano la bocca dell’urna per evitare una votazione affrettata, così parlò alla corte:
«Mi consola il fatto di aver vissuto così a lungo sempre nella vostra stima e perciò non posso consentire che, condannando costui sotto falsa accusa si commetta un vero e proprio assassinio, né che voi, chiamati a esercitare la giustizia sotto il vincolo del giuramento, fuorviati dalle menzogne di uno schiavo, diventiate voi stessi spergiuri. Almeno per quel che mi riguarda, io non posso calpestare il timore degli dei e venir meno alla mia coscienza pronunciando una condanna ingiusta.
«Perciò ascoltatemi e saprete come sono andate veramente le cose.
IX
«Questo furfante, non molto tempo fa, mi si presentò con cento monete d’oro sonanti dicendomi che aveva urgente bisogno di un veleno a pronto effetto per un malato che, colpito da un male inguaribile, voleva farla finita con una vita di sofferenze.
«Io, però, mi accorsi che questo sciagurato s’impappinava, adduceva confusi pretesti e così mi convinsi che stava macchinando qualche delitto.
«Allora gli detti il veleno, certo che glielo detti, ma prevedendo quanto prima un’inchiesta, non ritirai il compenso che mi aveva offerto: ‘Sta a sentire,’ gli dissi, ‘nel caso che qualcuna di queste monete fosse falsa o fuori corso, domani le controlleremo davanti a un banchiere.’
«Lui ci cascò e sigillò il denaro, così quando l’ho visto comparire in tribunale, ho detto a un mio schiavo di correre in bottega a prendere il sacchetto e di portarlo qui. Eccolo, io ve lo esibisco. E se lo guardi anche lui e dica che non e il suo sigillo. E allora, com’è che si può accusare il fratello se il veleno l’ha comprato costui?»
X
Allora questo mascalzone fu preso da un tremito convulso, perse il suo colorito naturale e divenne cadaverico, cominciò a sudar freddo per tutto il corpo e a non star fermo un momento con i piedi, a grattarsi continuamente la testa, a borbottare nella bocca semichiusa parole incomprensibili, così che ognuno capì che qualcosa sulla coscienza doveva avercela.
C’è da dire, però, che egli riprese quasi subito il controllo di sé e furbo com’era, cominciò a negare, anzi ad accusare il medico di mendacio.
Allora questi, vedendo che oltre l’autorità della corte si offendeva l’onorabilità della sua persona, raddoppiò la sua foga oratoria per confondere quel farabutto tanto che, su ordine dei magistrati, i pubblici ufficiali afferrarono le mani di quell’infame schiavo, gli strapparono l’anello di ferro e lo confrontarono con il sigillo del sacchetto: il raffronto confermò il sospetto iniziale. Si passò allora alla tortura e, all’uso greco, non gli furono risparmiati la ruota e il cavalletto. Ma egli oppose una resistenza eccezionale e non si piegò né alle frustate né al fuoco.
XI
Allora il medico: «No, non permetterò, perdio, non posso permettere che voi contro ogni giustizia condanniate a morte questo giovane innocente e che costui, prendendosi beffa di questo tribunale, sfugga alla pena che si merita per l’orrendo delitto commesso.
«Eccovi, allora, la prova decisiva del fatto in questione.
«Dunque, quando vidi che questo sciagurato insisteva per avere un veleno a effetto fulminante, subito riflettei che come medico io non potevo dare a un tizio qualunque sostanze che facessero morire ben sapendo che la medicina serve a guarire gli uomini non a ucciderli; però, temendo che se io gli avessi negato il veleno, non è che col mio rifiuto gli avrei tolta l’occasione di porre in atto il suo crimine in quanto egli se lo sarebbe procurato da un altro o avrebbe usato, alla fin fine, la spada o un’altra arma, io glielo diedi, ma era un sonnifero, quello famoso che si estrae dalla mandragora e che fa piombare in un letargo simile alla morte.
«Non c’è da stupirsi, quindi, se questo furfante sopporta la tortura; egli la ritiene ancora il male minore perché sa che per lui non c’è più speranza e che, secondo le leggi degli antenati, lo aspetta la pena di morte.
«Ma se è vero che quel ragazzo ha bevuto la pozione preparata da me, è vero anche che egli è vivo e che ora riposa e dorme e che fra poco, quando si ridesterà dal suo sonno profondo, tornerà alla luce del giorno.
«Se, invece, egli è morto bisognerà che voi cerchiate altrove le cause del suo decesso.»
XII
Con questo discorso il vecchio ebbe partita vinta e subito tutti si recarono di corsa al sepolcro dove giaceva composto il corpo del ragazzo. Non ci fu un senatore, un nobile, o anche uno solo del popolo che, spinto dalla curiosità, non vi accorresse. Ed ecco il padre, alzato con le proprie mani il coperchio della bara, vide che il figlio, proprio allora, stava destandosi dal profondo letargo e tornava dalla morte alla vita; e strettoselo forte fra le braccia, senza riuscire a dir parola per la troppa gioia, lo mostrò al popolo; poi, così com’era ancora avvolto nelle vesti funebri, lo portò in tribunale e la verità venne fuori e piena luce fu fatta sugli intrighi dell’infame servo e dell’ancor più infame moglie.
La matrigna fu condannata all’esilio perpetuo, il servo al patibolo e il bravo medico, su proposta unanime, in premio di quel sonno provvidenziale, s’ebbe le monete d’oro.
E fu proprio la mano della divina provvidenza a far concludere così l’avventura straordinaria e clamorosa di quel vecchio che dopo aver corso il pericolo di vedersi privato dei suoi due giovani figli, in poco tempo, anzi nel giro di qualche istante, si ritrovò padre di entrambi.
Apuleio
Fonte: Apuleio, Metamorfosi, a cura di Nino Marziano, Garzanti, Milano, 2008