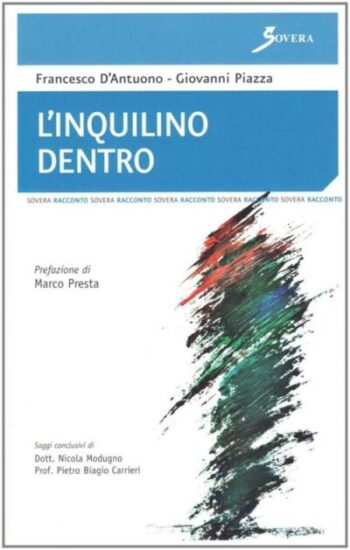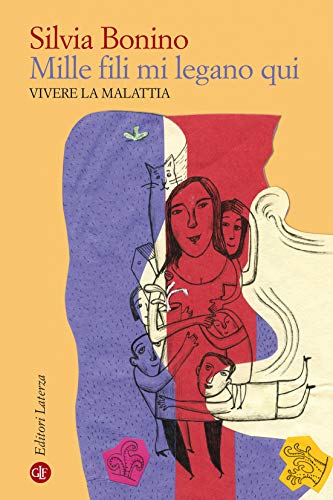Mio fratello rincorre i dinosauri. Storia mia e di Giovanni che ha un cromosoma in più
Down: una parola straniera? Una notizia travolgente? Un’etichetta? Una sindrome?
Una persona, un fratello, una questione di sguardo.
Abbiamo una cosa da dirvi… Riguarda vostro fratello.
Papà le strinse la mano.
– Vostro fratello… – disse, e fece una pausa. – Ecco, vostro fratello sarà… speciale.
Io e Chiara ci scrutammo l’un l’altra muovendo solo gli occhi.
– Speciale? – disse lei.
– In che senso speciale? – chiesi io.
– Nel senso, – disse papà, – che sarà… diverso. Affettuoso, anzitutto. Molto. Moltissimo. E poi sorridente e gentile. E tranquillo. E con i suoi, ecco, diciamo con i suoi tempi.
Sollevai un sopracciglio: – I suoi tempi?
– E altre cose sue speciali che ancora non sappiamo, – sorrise mamma.
– Quindi è una buona notizia? – chiese Chiara.
– Non è solo una buona notizia, – disse papà serio. Aggrottò la fronte in un modo buffo e la macchina cominciò a gonfiarsi e a sgonfiarsi come se stesse respirando con noi. – È molto di piú, – disse. – È una notizia travolgente –. Poi si girò e accese la radio. […]
– In che senso da dove arriva?
– Non è di questo pianeta. È evidente.
– Te l’avevamo detto, – disse lui, stringendomi la spalla con una mano cosí calda e ferma che con quella mano sulla spalla, giuro, sarei stato capace di andare ovunque nel mondo, affrontare qualunque cosa. – L’avevamo detto che era speciale.
Annuii.
Anzitutto gli occhi. Gli occhi erano cinesi, o venusiani forse, non sapevo decidermi; o di qualche altro pianeta con cristalli luminosi che sbucavano dalla sabbia e dieci lune viola nel cielo. Anch’io ho un taglio degli occhi un po’ orientale, in questo si vede che siamo fratelli, ma i suoi erano proprio tanto orientali. E poi la nuca. La nuca era piatta come una pista di atterraggio per microscopiche navicelle spaziali; se si fosse messo a quattro zampe potevi usarla come vassoio. Ma nulla mi colpí come le dita del piede che era scivolato fuori dalle coperte e che muoveva con scatti elettrici. Perché di dita, Giovanni, in quel piede, ne aveva quattro. O meglio, s’intuiva che potenzialmente erano cinque, ma il quarto e il quinto – il minolo e il pondolo – erano fusi insieme. Come due Kit Kat. […]
Aveva la copertina blu, un blu mogio e polveroso, e l’avevo intercettato già diverse volte, in camera da letto o sulla poltrona in salotto. Cosí, un giorno che stavo ciondolando per casa, finii per avvicinarmi e prenderlo in mano. Lessi l’autore, uno straniero, e il titolo, che conteneva anch’esso una parola straniera, e che quella parola era straniera lo sapevo perché c’era la lettera w. Noi non abbiamo tante lettere w o x nella lingua italiana, pensai. La parola era Down. La lessi pronunciandola: dovn. Prima di quella c’era la parola sindrome. Non sapevo cosa volesse dire sindrome, non sapevo cosa volesse dire Down. Lo aprii e, come sempre accade quando ci sono delle pagine piú spesse, il libro si spalancò su una fotografia.
Sgranai gli occhi. È Giovanni, pensai. […]
Ecco, allo stesso modo, interrogavo i miei genitori sui problemi di Gio. Sui suoi limiti, evidenti come il panino alla Nutella che mangiavo a merenda. E interrogavo soprattutto me stesso. Non mi interessavano piú le cause, quelle ormai erano cose passate. Pensavo piú che altro al suo futuro. Lui che non riusciva a imparare i numeri, come avrebbe fatto a pagare dal panettiere? Lui che aveva impiegato anni per parlare – e avrebbe sempre parlato male – come avrebbe fatto a scrivere? Se non sapeva né contare né scrivere, non avrebbe mai trovato un lavoro. Mi chiedevo perché avesse messo gli occhiali cosí presto: nessun altro bambino li portava. Mi chiedevo perché non ascoltasse niente, perché non capisse niente.
Addirittura – fu la cosa che mi sconvolse di piú – non avrebbe mai potuto fare le capriole. […]
Prima di quel giorno pensavo che il silenzio fosse assenza di rumore. Invece il silenzio è un suono, e c’è silenzio e silenzio. In quella mezz’ora, il silenzio mi parlò: mi disse che Gio aveva bisogno di me, costante bisogno di me; e io capii che ormai, senza Gio, non ci volevo piú stare a questo mondo. I suoi problemi erano i miei. E i miei problemi? A quelli ci avrei pensato da solo, senza disturbare; avrei trovato una soluzione. O almeno ci speravo. […]
Fu come il sole di mattina, quando filtra attraverso la tapparella che cerca di chiuderlo fuori e lui no, liquido e imprescindibile non si lascia imbrigliare, s’infila in ogni buco, in ogni fessura. Pensai ad Alice, alla sua reazione di fronte al bambino con il fucile. Pensai a Chiara, a quando aveva detto lascialo fare, che non è detto che le storie debbano sempre finire come sono state scritte. Ecco. Chi è che aveva scritto la nostra storia? Chi è che aveva sceneggiato la relazione tra me e Giovanni, e tra me, lui e il mondo, chi? Nessuno. Eravamo noi gli scrittori. Mia poi era la responsabilità di decidere come sarebbe finita la nostra storia. Nessuno instillava la paura del giudizio nel mio cuore, ero io a nutrirla.
Giacomo Mazzariol
Giacomo Mazzariol, “Mio fratello rincorre i dinosauri”, Einaudi, Torino, 2016