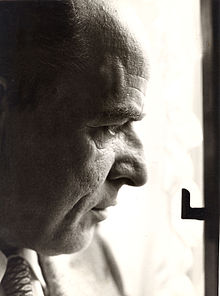Canto di Natale
Nel Canto di Natale di Charles Dickens, Tim, bambino storpio, che si aiuta con una stampella per camminare, confida nello spirito natalizio per essere accettato dalla comunità dei fedeli.
Così Marta si nascose ed entrò il piccolo Bob, il padre, con almeno tre piedi di sciarpa, senza contare la frangia, che gli pendeva davanti e i vestiti logori, rammendati e spazzolati che sembravano nuovi, e Tiny Tim sulle spalle. Povero Tim, portava una piccola stampella e aveva le membra sostenute da una struttura di ferro.
[…] <<Come si è comportato Tim?>>, chiese la signora Cratchit, dopo essersi burlata di Bob per la sua credulità e dopo che Bob si fu saziato di tenersi stretta la figlia.<<Buono come l’oro>>, disse Bob, <<e anche più buono. Qualche volta si mette a pensare, giacchè passa tanto tempo a sedere solo solo, e pensa le cose più strane che si possano immaginare. Tornando a casa, mi ha detto che sperava che la gente lo avesse visto in chiesa, perché era storpio e per loro poteva essere un piacere ricordarsi nel giorno di Natale di Colui che fece camminare gli storpi e vedere i ciechi>>
Nel dire queste parole, la voce di Bob tremava e si mise a tremare ancor più quando disse che Tim stava facendosi forte e coraggioso.
Si udì sul pavimento il rumore della sua piccola stampella, e Tiny Tim tornò indietro prima che fosse stata detta un’altra parola, scortato dal fratello e dalla sorella fino al suo panchetto accanto al fuoco.
[…] <<Dio ci benedica, ciascuno di noi!>>, disse Tim per ultimo. Stava seduto sul suo panchetto vicinissimo al padre, e Bob teneva nella propria la sua esile manina, come se avesse amato quel bambino, desiderato di tenerselo accanto e temuto che potessero portarglielo via.<<Spirito>>, disse Scrooge, con un interessamento che non aveva mai provato prima di allora, <<dimmi se Tim vivrà.>>
<<Vedo una sedia vuota>> replicò lo Spirito, <<nell’angolo di quel misero caminetto e una gruccia senza proprietario, conservata con ogni cura. Se queste ombre rimangono inalterate nel futuro il bimbo non morirà.>>
<<No, no>>, disse Scrooge. <<Oh no, Spirito buono. Dimmi che sarà risparmiato.>>
<<Se queste ombre rimangono inalterate nel futuro, nessun altro della mia razza>>, replico lo Spirito, <<lo troverò più qui, ma che importa? Se deve morire, è meglio che muoia e faccia diminuire la popolazione in sovrappiù.>>
Nel sentire lo Spirito citare le sue stesse parole, Scrooge chinò la testa e si sentì schiacciato dal pentimento e dal rimorso.
Charles Dickens
Charles Dickens, “Canto di Natale” (1843)