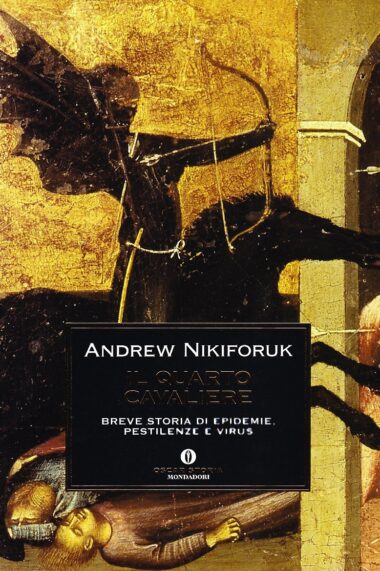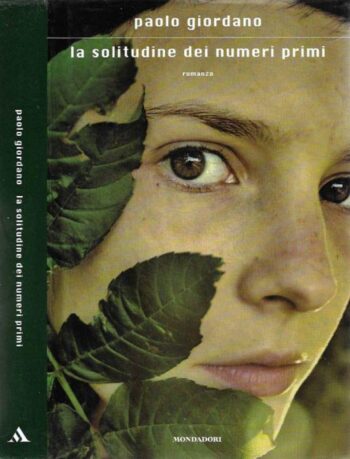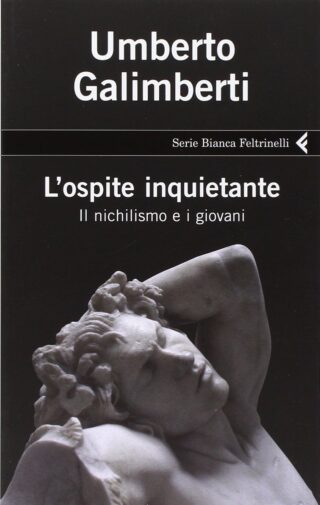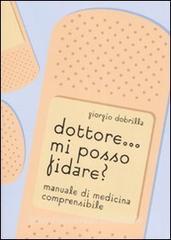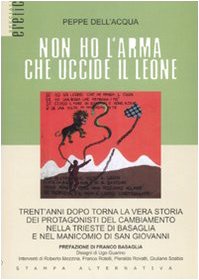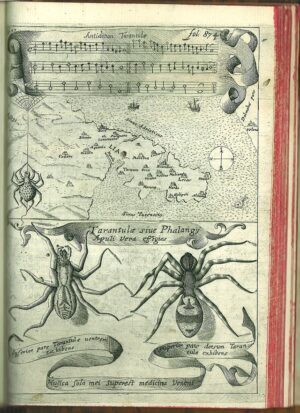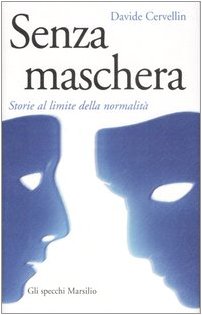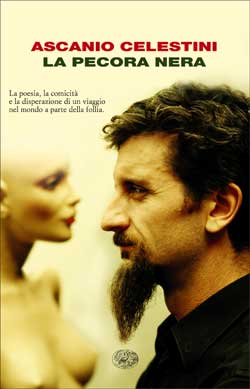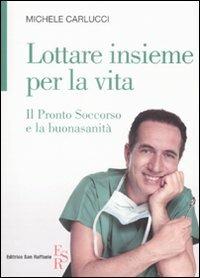“Il quarto cavaliere”: breve storia di epidemie, pestilenze e virus
Un saggio storico sulla convivenza tra l’uomo e malattie infettive, una riflessione sul ruolo delle pestilenze negli equilibri tra le civiltà umane, reso ancor più attuale alla luce degli sconvolgimenti causati dalla recente pandemia.
Uno dei saggi giustamente rimasti più celebri nella recente esegesi storica è “Armi, acciaio e malattie” di Jared Diamond, nel quale, sin dal titolo, un ruolo fondamentale viene assegnato alle epidemie nella evoluzione storica delle civiltà che ci hanno preceduto. Su questo elemento, “Il quarto cavaliere”, facendo riferimento alla celebre metafora dell’Apocalisse, esce adesso negli Oscar Mondadori un saggio specifico di Andrew Nikiforuk che traccia proprio una “breve storia di epidemie, pestilenze e virus”. Si tratta in realtà di uno studio dei primi anni ’90, come chiarisce l’autore in una nota nella quale precisa l’intento etico della sua opera: “Spero di spingere i lettori a condurre una vita più sana e a combattere per comunità più verdi, liberandosi dalle illusioni tecnologiche”. Un motto programmatico piuttosto deciso ed estremo, come si vede, che il giornalista canadese ripete incessantemente nei vari capitoli, spingendosi ad assiomi francamente sconcertanti come quello di annoverare tra “le grandi menzogne del XX secolo” quella che “gli antibiotici, i medici e i vaccini ci abbiano salvato”. Da un lato, insomma, l’autore si schiera decisamente contro lo scientismo e il progresso tecnologico, dall’altro rivanga come epoca aurea quella in cui l’umanità affrontava una vita di mera, dura sopravvivenza: “Gli uomini del passato, raccoglitori di noci con la lancia sotto il braccio, erano esemplari magnifici”, mentre i loro successori coltivatori “relativamente sedentari, erano individui curvi e affamati. Mangiavano troppi carboidrati e i loro denti marcivano”. Tutto questo, dunque, molto prima che arrivassero i fast food…
Se si prescinde da questo tipo di considerazioni, però, il libro è davvero interessante per la messe di informazioni storiche che fornisce in ordine al ruolo che malattie ed epidemie hanno assunto nello squilibrare i rapporti di forza tra gli Stati, le culture e le civiltà umane. Per esempio, quella sorprendente per cui “la malaria ha ucciso la metà degli uomini, donne e bambini che sono deceduti sulla terra” fino all’ultima guerra mondiale. Ciò su cui Nikiforuk ha certamente ragione è che il caso e l’eterogenesi hanno sempre giocato un ruolo determinante nel progresso umano, ad esempio la lebbra è sempre stata condizionata da fattori igienici e dunque, indirettamente, dalla disponibilità di tessuti per potersi cambiare più frequentemente d’abito: fu dunque la peste, diminuendo in modo spaventoso il numero di persone e aumentando le pecore e la lana pro-capite ad aiutare la scomparsa della lebbra in Europa. Tranne quella del Nord, dove essa restò diffusa molto più a lungo, in Norvegia addirittura fino a fine ‘800.
Marco Ferrazzoli
Andrew Nikiforuk, “Il quarto cavaliere” (Mondadori, 2008)
https://www.mondadoristore.it/quarto-cavaliere-Breve-Andrew-Nikiforuk/eai978880457834/