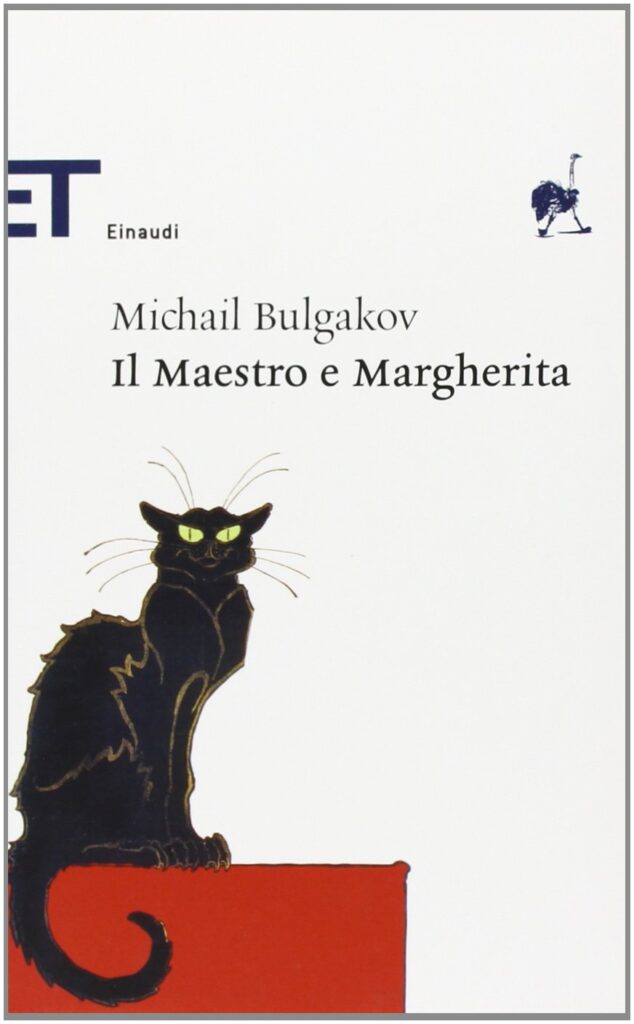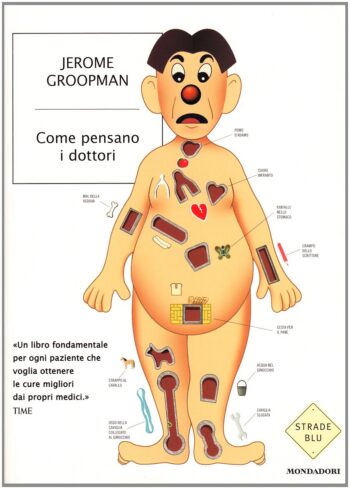La salute, nelle due facce della malattia e della medicina, della sofferenza e della cura, ricorre in tutte le letterature, spesso componendo un poliedro sfaccettatissimo. La letteratura francese non fa eccezione e anzi spalanca un panorama immenso, come delineato dagli spunti di questo breve saggio.
La salute, nelle due facce della malattia e della medicina, della sofferenza e della cura, ricorre in tutte le letterature con frequenza e rilevanza comparabili solo a quelle di pochi altri grandi temi esistenziali; e compone un poliedro sfaccettatissimo, qualunque punto di osservazione si assuma e qualunque prospettiva si traguardi: quelli dei personaggi, della trama, delle biografie degli autori, dell’uso metaforico o realistico del tema… La letteratura francese non può evidentemente fare eccezione e anzi spalanca un panorama immenso, in cui non è facile orientarsi né stabilire un percorso: limitiamoci pertanto, in questa sede, ad additare una serie di spunti utili per avventurarsi in successive esplorazioni[i].
Il mal di scrivere
Pensiamo solo al mare magnum della Recherche, dove anche una navigazione del tutto random ci fa continuamente imbattere in espressioni, metafore, descrizioni che non possiamo leggere senza ricordare come Proust associ una salute cagionevole all’essere figlio (oltre che fratello) di un medico: quell’Adrien che, all’epoca, vantava la fama di luminare per essersi distinto nell’adozione di un cordone sanitario con cui proteggere l’Europa dall’epidemia di colera del 1866. Come se in famiglia gli fosse spettato il ‘ruolo’ di malato, Marcel muore all’età di 51 anni per una polmonite che si era sostanzialmente rifiutato di curare, quasi in ossequio al suo professato scetticismo verso la medicina. Ad attestare questo suo duplice, controverso coinvolgimento sul tema basti questo brevissimo campionario di aforismi: “Come si dice in chirurgia, il suo amore non era più operabile” leggiamo in Dalla parte di Swann; ne I Guermantes che “Essendo la medicina un compendio degli errori successivi e contraddittori dei medici […] credere alla medicina sarebbe la suprema follia, se non credervi non fosse una ancora più grande”; in Sodoma e Gomorra che “La medicina ha compiuto alcuni piccoli progressi nelle sue conoscenze dai tempi di Moliére, ma nessuno nel vocabolario”; in Albertine scomparsa che “Ci si sente più vicini a chi ha le nostre stesse malattie”.
Potremmo rinvenire altri ricchissimi filoni di citazioni nelle miniere di Émile Zola e Victor Hugo, solo che si esplorino il Ventre di Parigi o I miserabili. Ma, per restare a Hugo, limitiamoci a ricordare come Notre Dame de Paris sia più popolarmente nota con il titolo de Il gobbo di Notre Dame, dato l’imporsi della figura di Quasimodo. Nell’affollato e prestigioso parterre delle deformità descritti nei classici è però doveroso quotare almeno un altro francese, il Cyrano di Edmond Rostand, e una delle scene più celebri della letteratura teatrale di ogni tempo (alla pari con la dichiarazione amorosa resa sotto il balcone di Rossana), quella che principia con la battuta di Valvert “Voi… voi avete un naso, ecco, un naso molto grande” e prosegue: “Ce n’erano di cose da dire sul mio naso – diamine! – e di toni da sfoggiare! Per esempio, vediamo…”.
Sembra persino troppo banale, su questo argomento, riportare il nome di Molière e i titoli del Malato immaginario e del Medico per forza. Meglio, tra tante perle rilucenti, ricordare come nel Gargantua si trovino forse le più emblematiche ed esagerate scariche diarroiche della narrativa: Pantagruel, peraltro, era medico e praticò a Lione, Metz e Roma. Come lo era Louis Ferdinand-Céline, che proprio grazie all’esercizio della professione restituì un barlume di senso alla sua travagliatissima esistenza, soprattutto nella fase finale. Nella diaristica potremmo azzardarci a tracciare un altro parallelo tra La doulou, autobiografico resoconto della sifilide che porterà Alphonse Daudet alla morte, e Je ne suis pas sortie de ma nuit in cui Annie Ernaux racconta l’Alzheimer che sta lentamente spegnendo la madre.
Il mal di vivere
I francesi vantano anche un autentico manifesto di uno dei leit-motiv poetici più forti del Romanticismo, la malinconia o mal du siècle: Le confessioni di un figlio del secolo di Alfred de Musset. Per restare nei pressi, troviamo una schiera inesauribile di autori, opere e personaggi iscrivibili nella ‘letteratura della follia’: dalle Memorie di un pazzo di Flaubert ad Antonin Artaud, con la sua vita vissuta tra dipendenze e ricoveri; da Rimbaud, malato sin da giovanissimo e poi paralizzato per una patologia su cui la diagnosi resta incerta tra cancro e sifilide, a Baudelaire, che dedica a Théophile Gautier i suoi Fiori del male definendoli “fleurs maladives”, cioè ‘malaticci’. Ma la tradizione dei maudit di ogni tempo potrebbe proseguire fino a un contemporaneo come Edouard Levé, che dopo aver consegnato Suicidio all’editore si è tolto la vita proprio come l’amico a cui si era ispirato, conferendo così al racconto un drammatico successo.
Sarebbe poi di estremo interesse un approfondimento sul “male di vivere” del ‘900: l’“esistenza ingiustificata”, per dirla con Sartre, che ne La nausea ci regala descrizioni di paradigmatico esistenzialismo: “Passava dal ciottolo nelle mie mani”, “La sento laggiù sul muro, sulle bretelle, dappertutto attorno a me. Fa tutt’uno col caffè, sono io che sono in essa”. Una scelta narrativa che è inevitabile contrapporre a quella de La peste di Camus. Il romanzo ambientato a Orano è di una precisione clinica assoluta, non a caso è un medico come Bernard Rieux a parlare dell’infezione “capace in tre giorni di tempo di quadruplicare il volume della milza, di dare ai gangli mesenterici il volume di un’arancia e la consistenza della pappa […] Si tratta d’una febbre a carattere tifoide, ma accompagnata da bubboni e da vomiti. Ho praticato l’incisione dei bubboni, si che ho potuto far eseguire delle analisi in cui il laboratorio crede di riconoscere il tozzo microbo della peste. Per dire tutto, aggiungo che certe modificazioni specifiche del microbo non coincidono con la descrizione classica”.
Ma tanta accuratezza è tutt’altro che uno sconto alla valenza allegorica attribuita al terribile flagello che, come una cartina di tornasole, evidenzia i contrasti più stridenti: tra l’indifferenza e la lentezza delle autorità e la violenza devastatrice, tra l’isolamento e la fuga e il disperato inseguimento dei piaceri o almeno della normalità della vita, tra il desiderio di salvarsi e gli inopinati gesti di solidarietà e altruismo, tra chi profitta della peste e chi la considera la nemesi delle colpe umane. L’opera si inserisce così tra le maggiori, per quanto concerne l’archetipo letterario delle epidemie che, affondate le radici nei classici – Edipo re, Iliade, Eneide… – si ramifica in una serie di capolavori immortali: L’alchimista di Ben Jonson, che attira le proprie vittime durante una pestilenza; il Decamerone, costruito proprio sul contrasto tra l’irriverenza delle cento novelle e dei loro personaggi e l’infuriare del morbo del 1348 descritto nell’introduzione; La peste di Londra, reportage giornalistico dell’epidemia che imperversò nel 1664-5 di Daniel Defoe; I promessi sposi ma anche la Colonna infame di Manzoni.
Da ciascuno di questi autori potremmo ricavare analogie e distinzioni con Camus. Ma il confronto più stimolante, anche per il contesto storico, è con La pelle in cui Malaparte narra “una peste profondamente diversa, ma non meno orribile, dalle epidemie che nel medioevo devastavano di quando in quando l’Europa. Lo straordinario carattere di tal nuovissimo morbo era questo: che non corrompeva il corpo, ma l’anima […] una specie di peste morale, contro la quale non pareva vi fosse difesa alcuna”.
Il mal francese
L’ultimo punto che vogliamo indicare quale possibile partenza per un percorso di sicuro interesse è l’agonia dall’esito infausto, utilizzata come escamotage narrativo. Un topos frequentatissimo dagli scrittori, dal quale potremmo inerpicarci in diverse comparazioni: per esempio, tra la morte di Charles Forestier nel Bel Ami e quella di Jean Péloueyre nel Bacio al lebbroso, a cui Guy de Maupassant e Francois Mauriac, rispettivamente, sembrano voler ricorrere per risolvere i loro ménage à trois lasciando ‘campo libero’ alla coppia superstite. Entrambi decideranno invece di proseguire il plot delle loro opere in direzione meno banale.
Potremmo anche affiancare la sorte toccata a Marguerite Gautier nella Signora delle camelie di Dumas a quella della perfida marquise de Merteuil nelle Liaisons dangereuses ordite da Choderlos de Laclos, che la sera stessa della sua espulsione da parte della società “fu presa da una violenta febbre che, in un primo momento, sembrò la conseguenza della brutale scena di cui era stata oggetto; ma ormai non c’è dubbio che si tratta di vaiolo, e in forma violenta. In verità, io penso che per lei sarebbe un bene morire”. La donna viene punita con un evidente contrappasso dopo che la Presidentessa de Tourvel, come madame de Volanges scrive alla signora de Rosemonde, cade vittima di un’affezione per la quale “i medici non sono in grado di pronunciarsi”, anche perché la stessa malata rifiuta ogni cura, fino al punto di “chiamare padre Anselmo, aggiungendo queste parole: ‘Adesso è la sola medicina di cui ho bisogno’”.
Stilemi che ritroviamo nella visione sinottica del Diario di un parroco di campagna di Georges Bernanos e de Le médecin de campagne di Honoré de Balzac. “Ogni romanzo di Bernanos è un romanzo dell’agonia”, è stato scritto, e indubbiamente tale è la storia del curato che, con puntiglio ma tardivamente e inutilmente, si impegnerà come medico di se stesso dopo che gli viene diagnosticato un tumore allo stomaco. Il Diario diviene la cartella clinica di una malattia che somatizza la mancata integrazione nella comunità del prete e la sua incapacità di reggere l’urto con la malvagità umana, specie dopo il sospetto che una bimba scomparsa sia rimasta vittima di un bruto: “Ho intuito la possibilità di un orribile, duplice delitto […] Rimasto solo, mi sono mosso per stendermi sotto una coperta […] è sopraggiunta mia sorella, la quale mi ha chiesto se mi sentivo male”. Alcuni tratti rimandano a Don Abbondio ma, al contrario del collega manzoniano, il giovane curato di Ambricourt è mosso da estrema compassione.
Nel Diario, malattia e sofferenza si presentano prima come disagio interiore dell’anima e poi come corruzione del corpo, sono individuali e sociali assieme, giacché investono la borghesia, il potere, la ricchezza, l’indifferenza. Il medico assume il ruolo di un alter ego del prete e quello del malato, più che di chi dovrebbe prendersene cura: l’asociale, emarginato e suicida dottor Delbende dirà al sacerdote “lei ed io siamo della stessa specie”, una frase del tutto analoga a quella del dottor Laville, “Vedendovi, poco fa, ho avuto l’impressione di trovarmi di fronte a… di fronte al mio doppio”. In questi personaggi, la morte è il culmine del fallito tentativo di riscattarsi dalle proprie origini umili elevandosi di status culturale e sociale.
In Balzac la figura del medico prende una fisionomia completamente diversa. Il dottor Bennassis, dopo una vita di delusioni, si ritira nel villaggio presso Grenoble, dove la cura dei cittadini travalica dalla competenza professionale all’impeto missionario e lo porta a diventare sindaco, dando modo a Balzac di tratteggiare un romanzo del ‘buon governo’. Lo stato di povertà in cui Bennassis vive, in “una camera nuda”, fedele a “una vita quasi monastica”, nella “più profonda noncuranza per tutto quello che non era una essenziale necessità” compone una figura quasi irreale, nel finale però il romanzo palesa come il caritatevole medico di campagna non sia mosso da semplice compassione o spirito di sacrificio ma da volontà di espiazione, essendo anch’egli un ‘malato’ afflitto da senso di colpa, dall’angoscia, dai rimorsi di gioventù, per aver sedotto una giovane donna che, rimasta incinta, finì con il suicidarsi.
Se volessimo evidenziare sbrigativamente due differenze, i protagonisti di Bernanos sono destinati alla resa, che nel caso più estremo consiste in un suicidio da cui Balzac parte invece per delineare un percorso riabilitativo. Il dottore creato da quest’ultimo raggiunge il proprio obiettivo mettendosi a capo di una comunità in cui, al contrario, il curato bernanosiano non riuscirà mai a integrarsi. Viene da pensare all’approccio narrativo diametralmente opposto degli Appunti di un giovane medico in cui Michail Bulgakov, lo scrittore celebre soprattutto per Il maestro e Margherita, romanzò i suoi ricordi di fresco laureato in medicina, repentinamente inviato a fronteggiare emergenze di pronto soccorso in una sperduta condotta russa agli albori della rivoluzione bolscevica. La concreta e motivata angoscia del giovane dottore, oltretutto inserita in una contingenza storica epocale e in una collocazione geografica estrema, si traduce in sketch narrativi di leggerezza straordinaria, spesso esilaranti.
Marco Ferrazzoli
[i] Questo saggio rappresenta il semplice stato dell’arte di un lavoro in corso, pertanto – e ce ne scusiamo con i lettori – non sono state indicate fonti né utilizzate note. Si ringraziano per la collaborazione Laura Battisti e Maria Gabriella Esposito.