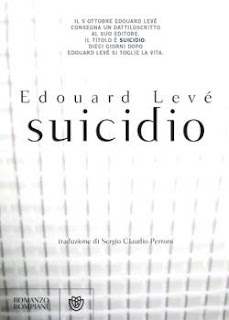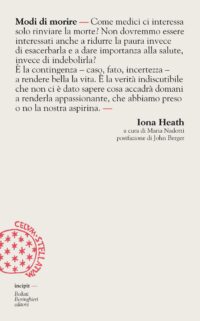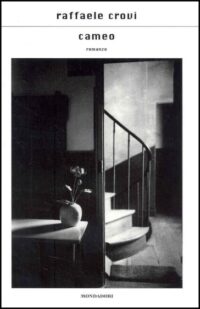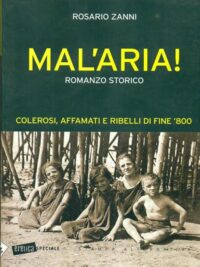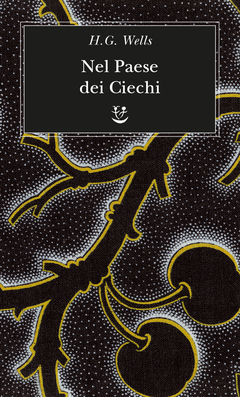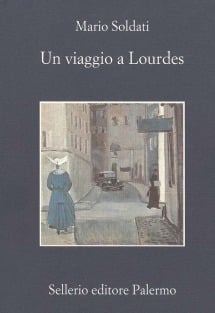L’incomprensibile suicidio di Edouard Levé
La vicenda editoriale legata a questo libro è tanto nota quanto drammatica: poco dopo aver consegnato il racconto per la pubblicazione, l’autore si è tolto la vita. Un atto imprevedibile, che si è trasformato in una terribile azione promozionale, rendendo il libro una sorta di diario ‘in tempo reale’ di una persona avviata verso il suo gesto estremo.
‘“Suicidio” rende tanti altri libri vani e inutili’, scrive L’Express in una delle recensioni che hanno segnato il clamoroso successo del libro di Edouard Levé, indissolubilmente legato all’esito imprevedibile e drammatico della vicenda editoriale: poco dopo aver consegnato il racconto per la pubblicazione, l’autore si è tolto la vita. Un atto imprevedibile, che si è trasformato in una terribile azione promozionale, rendendo il libro una sorta di diario ‘in tempo reale’ di una persona avviata verso il suo gesto estremo.
Lo spunto per il libro era giunto a Levé dal suicidio compiuto da un conoscente molti 25 anni prima: l’uomo era rientrato in casa con una scusa, mentre si stava recando ad una partita di tennis con la moglie che, udito lo sparo, era rientrata trovandolo senza vita. Lo scrittore cerca di immedesimarsi con l’amico, tenta di fornire una spiegazione a quella scelta, ma l’impressione che si ricava dalla lettura che in simili frangenti non si possa dire nulla di significativo. Il suicida resta incomprensibile all’autore, come Levé lo è, doppiamente, per noi.
Da un lato Levé, con la retorica di alcune espressioni, sembra ammantare il suicida della scontata mitologia che accompagna queste persone: ‘Nell’arte togliere equivale a migliorare. Scomparendo ti sei perpetuato in una bellezza negativa’; ‘Il tuo suicidio è stato un’azione a effetto inverso: una vitalità che produce morte’. Dall’altro lato, pare condividere l’accusa di egocentrismo che spesso viene rivolta a chi si uccide: ‘Non potevi accettare di mentire a quella semplice domanda: come stai?’, ‘Ti stupiva che i tuoi stati d’animo potessero essere tanto mutevoli senza che nessuno se ne accorgesse’.
Ma probabilmente il suicida non è un ragazzino immaturo né un eroe romantico. E forse, più dei suicidi, è facile spiegare i suicidi ‘mancati’. Più di questo libro ci appare vicina, nella sua inconsolabile tristezza, l’ingenuità dell’adolescente che scrive a uno psicologo da settimanale: ‘L’unico motivo per cui non oso togliermi la vita non è la paura. È che non so come si sta dopo’.
Marco Ferrazzoli
Edouard Levé, “Suicidio” (Bompiani, 2007)